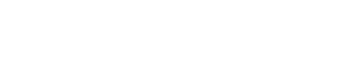Questione organizzativa: la struttura sociale organizzativa
2. La struttura sociale organizzativaSecondo la sociologa americana Mary Jo Hatch6, le organizzazioni conducono i loro membri a interagire regolarmente gli uni con gli altri. La teoria della strutturazione considera queste ripetute interazioni come il fondamento della struttura sociale.Quando le interazioni si verificano regolarmente, la struttura sociale diventa più visibile. Tuttavia, anche interazioni non ripetitive e persino la mancanza totale di interazione fra certi gruppi contribuiscono alla struttura sociale di un’organizzazione. Nella prospettiva del studioso americano Anthony Giddens7, la visione tradizionale della struttura sociale come vincolo all’interazione si allarga fino a suggerire che è l’interazione stessa a creare la struttura dei condizionamenti alla quale è sottoposta. Secondo la visione strutturazionista, la struttura è fatta da individui interagenti, che essa condiziona persino nel momento stesso in cui essi pongono in essere quegli schemi di interazione che riconosciamo poi come struttura. Questa idea è chiamata “dualismo della struttura”. La tesi del dualismo della struttura sostiene che le strutture sociali condizionano le scelte degli esseri umani riguardo alle proprie attività; contemporaneamente, però, le strutture sociali vengono create dalle stesse attività che condizionano. In questa visione, le strutture non si limitano a condizionare l’interazione, ma anzi la rendono possibile. La teoria della strutturazione enfatizza i piccoli cambiamenti e le continue dinamiche che si verificano all’interno delle strutture sociali. La struttura sociale non è vista come un oggetto fisso e immobile, ma come un delicato momento di cooperazione composto da interazioni mutevoli o anche da loro semplici abbozzi -il tutto sostenuto dalla complicità degli individui che ne sono coinvolti in luoghi e momenti specifici.
2.1 Le componenti fondamentali della teoria dell’organizzazione analizzate attraverso la prospettiva modernista e quella simbolico-interpretativa
In questo paragrafo descriveremo brevemente gli aspetti organizzativi sui quali i teorici dell’organizzazione fondano le loro teorie, che sono: l’ambiente organizzativo,la strategia, la tecnologia, la cultura e la struttura fisica. Questo approfondimento servirà a farci comprendere quanto questi cinque elementi, appena elencati, siano determinanti nello studio e nell’analisi della struttura sociale organizzativa. Per descrivere questi cinque fondamentali concetti mi servirò delle due principali correnti teoriche dell’organizzazione, quella modernista (o funzionalista) nata negli anni ’50 con Parsons, Simon, e quella simbolico-interpretativa ( o semplicemente interpretivista), nata negli anni ’80 con Berger, Luckman, Weick e Goffman. La corrente funzionalista parte dal presupposto che il mondo sussista a prescindere dalla nostra conoscenza di esso, dunque l’organizzazione è qualcosa di misurabile: l’approccio modernista ha studiato l’organizzazione attraverso percezioni oggettive, tramite metodi che comprendono le misure descrittive e la ricerca di correlazione tra misure standardizzate. Negli anni ’50, il biofisiologo Ludwig von Bertalanffy, ha elaborato una teoria atta a spiegare tutti i fenomeni scientifici, nell’ambito sia delle scienze naturali, sia delle scienze sociali. Bertalanffy parte dall’assunto che il metodo scientifico implica, o quantomeno consente, una certa unità teorica, in nome della quale egli operò a un tale livello di astrazione che, all’interno della sua teoria, potrebbero ritrovarsi ed integrarsi tutte le conoscenze scientifiche nella loro essenza.La sua teoria si chiama “teoria generale dei sistemi”, dove un sistema è un qualcosa fatto di parti correlate tra loro e ciascuna parte ha un ‘influenza sulle altre parti e, al tempo stesso, dipende dalle caratteristiche e dal funzionamento del sistema nel suo complesso. Per i simbolico-interpretativi, invece, tutto ciò che si sa sul mondo, sempre ammesso che esso esista, viene filtrato attraverso le forze cognitive di chi lo osserva, ma anche attraverso forze culturali e sociali più ampie. Quest’ultima corrente studia le organizzazioni attraverso le percezioni soggettive, e le analizza tramite l’osservazione partecipante e le interviste etnografiche8. La corrente simbolico-interpretativa è caratterizzata dalla frattura che l’analisi delle organizzazioni, intese come culture, opera rispetto al valore indiscusso della razionalità. Se, dunque, le organizzazioni non esistono indipendentemente da quanti le producono, le teorie che le interpretano si appuntano maggiormente sui processi dell’organizzare, rispetto all’organizzato, ovvero all’organizzazione in quanto prodotto dell’attività umana. La teoria alla quale fa riferimento questa corrente è quella dell’enactment, elaborata dallo psicologo americano Karl Weick nel 1979 nel suo libro “The social psychology of organizing”. Secondo questa teoria, quando noi usiamo concetti, come l’organizzazione, in effetti stiamo creando il fenomeno stesso che cerchiamo di analizzare. Dunque, vengono sottolineate le origini soggettive delle realtà organizzative, in un’ottica secondo la quale si rende reale un fenomeno parlando e agendo in modi che gli danno tangibilità. La realtà viene definita oggettivata, ovvero costruita socialmente in modo da farla sembrare soggettiva, per cui, anche le categorie di linguaggio utilizzate per studiare le organizzazioni, non sono reali o naturali in senso oggettivo: piuttosto, sono il prodotto delle credenze dei membri di una società, che inventano e sostengono i significati dei termini che usano per comprendere ed interpretare il mondo.
2.1.1 L’ambiente organizzativo
E’ della teoria funzionalista ( o modernista) degli anni ’50 l’idea di considerare l’ambiente come qualcosa che si trova fuori dai confini fisici di un’organizzazione, ma che ne influenza gli esiti tramite l’imposizione di vincoli come quello dell’adattamento per la sopravvivenza. Per i funzionalisti l’ambiente organizzativo è definito dai suoi componenti: il network interorganizzativo, nel quale l’organizzazione stessa interagisce con altri componenti del suo ambiente; l’ambiente generale, che è definito come l’insieme di forze generali e di varia natura che si muovono nell’ambiente divise in settori di influenza; l’ambiente globale, che include alcuni aspetti che si estendono oltre i confini nazionali delle organizzazioni prese in considerazione o che sono organizzati su scala globale. In realtà quando parliamo di ambiente non possiamo fare una distinzione così netta come volevano i funzionalisti: non esistono ambienti separati o diversi, ma un unico ambiente complesso, che ingloba anche le stesse organizzazioni e i diversi settori. I teorici dell’interpretivismo simbolico degli anni ’80, invece, ritengono che l’ambiente sia qualcosa di diverso. A questo proposito, Mary Jo Hatch spiega che nella prospettiva simbolico–interpretativa l’ambiente ha un impatto senz’altro materiale ma anche e soprattutto simbolico; quanto sia importante l’ambiente dipende da come viene interpretato questo impatto.
2.1.2 La strategia
La teoria funzionalista si è più occupata del concetto di strategia, rispetto all’interpretivismo. Per essa la strategia è lo sforzo dei quadri dirigenti di influenzare gli esiti organizzativi gestendo il rapporto organizzazione-ambiente a loro favore. Si inizia con un’analisi dell’organizzazione e del suo ambiente, per passare poi alla formulazione della strategia e, solo alla fine, alla sua attuazione effettiva. L’obiettivo di ogni strategia è raggiungere un fit strategico, un concetto che definisce di successo una strategia che porta l’organizzazione a conformare le sue competenze ai bisogni e alle domande del suo ambiente. Diversa è l’opinione dei simbolico-interpretativi,che ritengono la strategia come un’azione simbolica, che deve essere prima attuata e poi analizzata nei suoi effetti. Essi mettono in discussione la relazione che opera il modello funzionalista tra le diverse fasi dell’analisi, della formulazione e dell’attuazione della strategia. La loro ipotesi è sostenuta da alcuni studi condotti su organizzazioni giapponesi, all’interno delle quali l’azione normalmente precede la dichiarazione pubblica di piani programmatici, ovvero in cui l’attuazione precede l’analisi e la formulazione, invece di seguirle. Si è dimostrato che questo processo, per così dire, inverso, serve a legittimare ciò che è già stato fatto, comunicando simbolicamente agli altri membri dell’organizzazione l’apertura del management verso nuove idee. Karl Weick9, noto sociologo americano, ha anche sostenuto che l’azione può produrre la strategia. Questa è una visione più radicale, la quale sostiene che la fase della formulazione della strategia non ha mai luogo, e che la strategia viene piuttosto prodotta da azioni di successo che si sviluppano nel corso dell’esperienza. Secondo Weick “l’esecuzione della strategia è l’analisi, e l’attuazione è la formulazione”. Per lui, i manager, continuano a dimenticare che è quello che fanno, non quello che pianificano, che spiega il loro successo. Essi continuano a dare il merito del loro successo alla cosa sbagliata e, una volta commesso questo errore, passano più tempo a pianificare e meno ad agire e, poi, si stupiscono quando si accorgono che, una maggiore pianificazione, non migliora affatto le cose.
2.1.3 La tecnologia
Per i modernisti la tecnologia è un mezzo per raggiungere un obiettivo; in particolare, è l’insieme dei metodi e delle conoscenze che consentono ad un’organizzazione lo svolgimento delle sue attività. La tecnologia di un’organizzazione è definita sulla base di: oggetti fisici, inclusi prodotti, strumenti e attrezzature di produzione; attività e processi, inclusi i metodi di produzione; conoscenze necessarie a sviluppare e ad attivare gli impianti, gli strumenti e i metodi di produzione utilizzati per ottenere un determinato risultato. I simbolico-interpretativi parlano, invece, di costruzione sociale della tecnologia, criticando i modelli modernisti dell’innovazione tecnologica, che vedono le innovazioni come qualcosa che nasce dalla scienza pura e si sviluppa, fase per fase, fino ad arrivare alla ricerca applicata, alla produzione, al marketing e infine al consumo da parte dei consumatori. Al contrario, la tecnologia non viene studiata dai simbolico-interpretativi come semplice applicazione di scoperte scientifiche, ma viene analizzata nelle sue influenze sociali e culturali: essi esaminano dettagliatamente il contesto in cui si sviluppano nuovi prodotti e le loro tecnologie. I sostenitori di questa prospettiva ritengono che le tecnologie non si evolvono in modo inevitabile, ma in modo flessibile, in base a criteri come i valori culturali, le norme sociali e le considerazioni di potere: il sociale e il tecnologico si costituiscono l’un l’altro. I ricercatori che si interessano della costruzione sociale della tecnologia, partono da due assunti fondamentali: uno è che la tecnologia rispecchia ed è influenzata dalle scelte complesse che costituiscono la nostra società, l’altro è che le tecnologie non devono essere per forza quello che sono. Quindi, secondo questo approccio, nella scelta e nell’applicazione di una tecnologia, concorrono molti più elementi di quanti ne ritenessero i modelli lineari modernisti. In definitiva, possiamo riassumere il loro pensiero così: la tecnologia influenza la società, tanto quanto la società influenza la tecnologia.
2.1.4 La cultura
I modernisti interpretano la conoscenza della cultura come uno strumento nelle mani del management, e considerano la cultura stessa come una variabile da manipolare per aumentare la probabilità di ottenere certi auspicati livelli di rendimento dagli altri membri dell’organizzazione. Gli autori simbolico-interpretativi, d’altro canto, definiscono la cultura come un contesto per creare significati e interpretazioni. Dal loro punto di vista, la conoscenza degli assunti e dei valori culturali ci aiuta a capire noi stessi in relazione alle persone che ci circondano.Se conosciamo a fondo questi rapporti possiamo penetrare nella cultura – la nostra e quella degli altri. Si parte dall’assunto che le culture sono realtà socialmente costruite, riferendosi all’idea che la realtà non è tanto rappresentata dalle condizioni del mondo fisico o naturale, ma è piuttosto definita attraverso legami e accordi interpersonali. Questo approccio si preoccupa di descrivere come le realtà organizzative vengano costruite socialmente: gli esseri umani partecipano alla costruzione sociale della vita organizzativa quando creano, usano e interpretano simboli e sono sensibili alle interpretazione degli altri. L’uso e l’interpretazione di simboli consente ai membri di un’organizzazione di creare e mantenere la propria cultura. Pertanto, è proprio osservando la costruzione e l’utilizzo dei simboli che, il ricercatore simbolico-interpretativo, arriva a conoscere la cultura. La più importante teoria della cultura organizzativa è quella dello psicologo sociale Edgar Schein10, il quale afferma che la cultura è costruita su livelli differenti, che sono: assunti, norme e valori, artefatti. Gli assunti si trovano al centro della cultura di un’organizzazione e sono verità certe, perlopiù inconsce, che gli uomini danno per scontate. Le norme sono regole non scritte che permettono agli individui di conoscere le aspettative all’interno della propria cultura, ovvero quali sono i comportamenti da adottare e quali invece da evitare, mentre i valori definiscono ciò che sta a cuore ai membri di un’organizzazione, in termini di codici morali ed etici. Gli artefatti, invece, sono espressioni visibili, tangibili ed udibili di comportamenti fondati su norme, valori ed assunti culturali. Sia i modernisti che i simbolico-interpretativi ritengono che gli assunti e i valori influenzino il comportamento attraverso norme e aspettative, e che comunichino identità attraverso simboli, tradizione e usi comuni.
2.1.5 La struttura fisica
Pfeffer11 ritiene che, dal punto di vista dell’approccio modernista, la struttura fisica di un’organizzazione incoraggia e al tempo stesso vincola la comunicazione delle informazioni e delle idee, e il coordinamento di attività interdipendenti. Gli studi comportamentali, di matrice modernista, si sono tradizionalmente concentrati sul rapporto tra la struttura fisica di un’organizzazione e il comportamento degli individui confinati in determinati spazi al suo interno. L’idea fondamentale è che, visto che gli esseri umani non possono passare o vedere attraverso i muri, il loro comportamento deve essere per forza influenzato dal design dell’ambiente fisico dell’organizzazione. Per l’approccio simbolico si parla invece di condizionamento simbolico, in cui l’importanza risiede nel legame inconscio tra struttura fisica e le normali routine che scandiscono la vita quotidiana all’interno delle organizzazioni: ancora una volta questo approccio guarda più all’essenza del concetto che non ai suoi effetti tangibili.
2.2 La teoria delle contingenze
La teoria che andremo ad affrontare costituisce il punto di partenza per analizzare tutti gli elementi che definiscono la struttura sociale organizzativa. Secondo questa concezione non esiste un modo universale per poter rappresentare la struttura di un’organizzazione: la struttura più appropriata è contingente al tipo di ambiente in cui si trova l’organizzazione; ciò significa che non ci sono forme organizzative migliori di altre, ma solo più convenienti ed adeguate. Questa teoria fu elaborata tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60 dai sociologi Tom Burns e Gorge Stalker, che si basarono sull’ipotesi che le organizzazioni differiscano nella forma in relazione al tipo di ambiente in cui si trovano ad operare: stabili o in rapido mutamento. In ambienti stabili, le organizzazioni si specializzano in attività di routine, con rigide linee di autorità e distinti compiti o aree di responsabilità. Utilizzando la metafora della macchina, possiamo definire queste organizzazioni “meccanicistiche”. Le macchine consistono di parti specializzate messe insieme e attivate in modo da svolgere certi compiti in modo molto efficiente. Così, le organizzazioni meccanicistiche consistono di parti specializzate (i diversi compiti e lavori svolti dagli impiegati) che vengono attivate dai manager per funzionare in modo molto efficiente. In ambienti in rapida evoluzione, le organizzazioni hanno bisogno di flessibilità e gli impiegati sono incoraggiati ad adattarsi alle richieste fluttuanti del mercato del lavoro – modificando le proprie capacità a seconda della necessità, e nella maniera che ritengono più conveniente. I teorici modernisti delle organizzazioni definiscono questo tipo di organizzazioni “organicistiche” perché, come tutti gli esseri viventi si adattano in modo flessibile a circostanze mutevoli. Le organizzazioni organicistiche hanno meno specializzazione interna e sono meno formalizzate e gerarchiche di quelle meccanicistiche; inoltre comunicano in modo meno rigido e molto più informale. In ambienti stabili, la forma meccanicistica è preferibile per l’efficienza che crea utilizzando procedure standardizzate atte a svolgere attività di routine. In queste condizioni le organizzazioni possono imparare a ottimizzare le proprie attività minimizzando i costi e massimizzando i profitti. In situazioni in rapido mutamento, tuttavia, la forma meccanicistica non è più così conveniente. I vantaggi e la logica stessa della routinizzazione si perdono quando l’organizzazione deve costantemente modificare le proprie attività per adattarsi ai rapidi cambiamenti dell’ambiente. La flessibilità tipica delle forme organicistiche di organizzazione è preferibile in un ambiente in continuo cambiamento perché è in grado di sostenere i necessari processi di innovazione e di adattamento. Anche se oggi questa teoria è stata superata da altre idee che danno per scontato l’importanza dell’ambiente per le organizzazioni, essa è ancora presa come punto di partenza per molte discussioni che analizzano il rapporto tra ambiente ed organizzazione.
2.3 Rappresentazione e descrizione della struttura sociale organizzativa
I teorici e i manager utilizzano determinati schemi, detti organigrammi, per rappresentare e descrivere i diversi tipi di struttura sociale organizzativa. Qui di seguito riporterò le principali tipologie di struttura sociale, con relativi organigrammi e descrizioni. Non bisogna dimenticare che l’organigramma non dà molte informazioni circa i meccanismi reali di distribuzione del potere, coordinamento o relazioni informali. La sua funzione è quella di rilevare gerarchie formali di autorità, divisione del lavoro e ripartizione dei compiti all’interno di un’organizzazione. Le principali tipologie di struttura sociale sono: struttura semplice, struttura funzionale, struttura multi-divisionale e struttura a matrice.
2.3.1 La struttura semplice
La struttura semplice non è elaborata, non c’è una divisione rigida dei compiti e la gerarchia manageriale è poco sviluppata. Si tratta di una struttura organica: riprendendo la teoria delle contingenze, possiamo affermare che questo tipo di struttura è presente principalmente in ambienti dinamici, in continuo cambiamento; non essendo complessa, infatti, essa riesce con facilità ad adattarsi continuamente alle variazioni dell’ambiente. Di solito la struttura semplice rappresenta lo stadio iniziale dal quale partono quasi tutte le organizzazioni, poiché è facile da gestire e non comporta alcun rischio di incomprensione al suo interno. Non può essere rappresentata con un organigramma proprio per la sua essenzialità.
2.3.2 La struttura funzionale
Nel momento in cui la complessità di un’organizzazione aumenta a tal punto che una struttura di tipo semplice non è più sufficiente a gestirne i compiti, un’azienda adotta una struttura di tipo funzionale, chiamata così perché raggruppa attività che sono simili sul piano della funzione lavorativa. In genere, questa struttura dà ai top manager un forte potere di controllo sugli operati degli altri membri dell’organizzazione, in quanto essi hanno una visione generale e molto efficace di tutte le aree di attività e dei relativi compiti assegnati. Dunque essa è utile ad ogni livello organizzativo in quanto fornisce precise informazioni sulle funzioni di ogni settore aziendale. Nell’organigramma sono riportate le funzioni principali di un’organizzazione in genere, quali: la produzione, le vendite, gli acquisti, l’ingegneria e la contabilità.
2.3.3 La struttura multi-divisionale
Quando c’è un sovraccarico di responsabilità all’interno di un’organizzazione che ha una struttura di tipo funzionale, si arriva ad adottare una forma multi-divisionale. La struttura multi-divisionale può essere descritta e rappresentata come un insieme di strutture funzionali distinte, ognuna delle quali è collegata direttamente con la direzione generale. La forma multi-divisionale raggruppa settori, funzioni e persone in base a tre diversi criteri di somiglianza: per funzione o per prodotto; per tipologia di clientela; per locazione geografica. Il vantaggio delle strutture multi-divisionali su quelle funzionali risiede nelle sue dimensioni: essendo più grandi, riescono a gestire meglio il rapporto con l’ambiente circostante, quindi sono più determinate in termini di competitività
2.3.4 La struttura a matrice
La struttura a matrice nasce dalla coniugazione delle parti migliori della struttura funzionale e di quella multi-divisionale: l’efficienza e la flessibilità. Non ci sono distinzioni tra le diverse aree in base al prodotto, al tipo di cliente o all’area geografica. Si può pensare ad essa come a due tipi di strutture combinate, una che presenta delle funzioni e l’altra i progetti organizzativi, ciascuna delle quali viene gestita da un diverso team di manager che ne è responsabile. Inoltre qui ci sono due tipi di manager: il primo è quello funzionale, che ha il compito di assegnare i progetti a determinati specialisti, di sostenerli nel mantenimento di elevate capacità tecniche e di controllare la loro professionalità. Il secondo tipo di manager è quello di progetto, che coordina la parte più specifica del lavoro, quella che riguarda i bilanci, i tempi e i modi di attuazione di un piano di lavoro. Proprio per l’esistenza di queste due differenti linee di autorità,alle quali i membri dell’organizzazione sono soggetti, c’è difficoltà nel gestire senza contrasti le domande che provengono dai diversi manager. Nonostante questo problema, la struttura a matrice sembra la più vantaggiosa tra le altre tipologie di struttura, in quanto coniuga egregiamente flessibilità, prontezza ed efficienza.