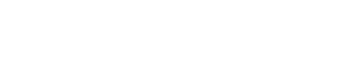Aspetti semiotici, sociologici e culturologici della pubblicità
2.1 I Miti di Barthes
Secondo Roland Barthes15, un articolo di giornale, una fotografia, un film o una pubblicità sono tutti “miti”, miti contemporanei dotati di un significato16. 'Il mito è una sorta di linguaggio rubato', dice Barthes, 'è riversamento in naturale di ciò che è culturale'. Questa frase acquista il suo senso completo pensando alla mitologia come disciplina che farebbe al tempo stesso parte sia della semiologia, come scienza formale, sia dell’ideologia come scienza storica; il mito si definisce così una continua riproduzione nel tempo di sapere stereotipato e banalizzante. Ogni messaggio pubblicitario colpisce un destinatario e punta a persuadere il soggetto attraverso anche la filosofia degli stereotipi. Il linguaggio pubblicitario è secondo Barthes sempre rubato perché rende in maniera naturale ciò che è costruzione artificiale. In questo modo la naturalezza si confonde con bellezza ed il messaggio arriva al soggetto attraverso meccanismi retorici. Dato che un semiologo è colui che quando si guarda intorno, là dove gli altri vedono solo fatti ed eventi, scorge significazione17, così le analisi di Barthes non riguardano solo ciò che un’immagine vuole dire, bensì egli afferma e dimostra che, in ogni caso, un evento dice sempre qualcosa. Nell’analisi di alcuni miti della vita quotidiana francese, il semiologo tratta il mito come linguaggio e, analizzando quella che chiama “cultura di massa”, mette in luce le contraddizioni ed i significati del mondo di oggi. Barthes scrive i testi di Miti d’oggi fra il 1954 e il 1956, mentre il libro appare solo nel 1957. In questo libro, il riferimento che gli piace più utilizzare per guardare alla vita delle donne è il settimanale francese “Elle”, del quale compie un’attenta analisi, parlandone come fosse un mondo a sé. Barthes arriva a definirlo “vero tesoro mitologico”, soprattutto perché è letto da ambienti a basso reddito, quindi da un pubblico popolare che è proprio quello che interviene attivamente nella costruzione dei miti e della cultura di massa. Egli scrive:
“ Tale è il mondo di “Elle”: qui le donne sono sempre una specie omogenea, un corpo costituito, geloso dei suoi privilegi e ancor più amante delle proprie catene; al suo interno l’uomo non c’è mai, la femminilità è pura, libera, potente; ma intorno l’uomo è dappertutto, preme da tutte le parti, fa esistere; egli è l’eterna essenza creatrice, quella del dio raciniano; mondo senza uomini, ma interamente costituito dallo sguardo dell’uomo, l’universo femminile di “Elle” è in tutto e per tutto quello del gineceo”. (Barthes,1994: p.49]
L’immagine della donna descritta da Barthes attraverso le pagine di questo giornale francese è quella di una donna che non deve mai dimenticare di essere diversa dall’uomo e a lui sottomessa, come se questo fosse un disegno del destino che non può essere mai cambiato. Barthes, rivolgendosi alle donne, dice loro: amate, lavorate, scrivete, siate donne d’affari o di lettere, ma ricordatevi sempre che l’uomo esiste e che non siete fatte come lui: il vostro ordine è libero a condizione che dipenda dal suo: la vostra libertà è un lusso, è possibile solo se prima riconoscete gli obblighi della vostra natura. Scrivete, se volete, tutte ne saremo fiere; ma ricordatevi anche di fare figli, perché è nel vostro destino. Morale gesuitica: venite pure a patti con la morale della vostra condizione, ma non cedete mai sul dogma che la fonda. Anche durante la sua infanzia la bambina possiede alcuni giocattoli che svolgono la funzione di ricordarle il suo destino, esistono per esempio delle bambole in grado di orinare; hanno un esofago, si può dare loro il biberon, bagnano le fasce, presto, certamente, il latte nel loro ventre si trasformerà in acqua. Con questo si vuol preparare la bambina alla causalità domestica, “condizionarla” al suo futuro ruolo di madre. Inoltre, all’interno delle diverse rubriche del settimanale francese “Elle” ne esiste una che attira maggiormente l’attenzione di Barthes: la “Posta del Cuore”, all’interno della quale si trovano le risposte della Redazione del giornale alle lettere inviate da donne comuni che le sottopongono domande su problemi di varia natura, per lo più di natura sentimentale, e che vogliono un consiglio sulla propria situazione. Barthes, affermando che il cuore è l’organo femminile per eccellenza, esprime un giudizio sulla “Posta del Cuore” e sui suoi interlocutori. Per quanto riguarda le donne che scrivono, afferma Barthes che, in ciò che la Piccola Posta intende rivelarci di esse, le consultanti sono accuratamente spogliate di ogni condizione: come sotto lo scalpello imparziale del chirurgo l’origine sociale del paziente è messo generosamente tra parentesi, così sotto lo sguardo della consigliera la postulante è ridotta a un puro organo cardiaco. La definisce solo la sua qualità di donna: la condizione sociale è trattata come un’inutile realtà parassita, che potrebbe intralciare la cura della pura essenza femminile. In relazione alla Redazione del giornale e al tipo di rubrica che è la “Posta del Cuore”, l’autore sostiene che l’umanità della “Posta del Cuore” riproduce una tipologia essenzialmente giuridica: lungi da ogni romanticismo o da ogni investigazione un po’ reale della vita vissuta, la posta segue nel modo più aderente un ordine stabile delle essenze, quello del Codice civile. Il mondo-donna è diviso in tre classi, di statuto distinto: la puella (vergine), la coniux, e la mulier (donna non sposata, o vedova, o adultera, ma in ogni modo attualmente sola e con un passato). Considerando, sempre in riferimento a questa rubrica giornalistica, il rapporto della donna con il matrimonio in quegli anni, troviamo scritto che:
“In questo mondo di essenze, l’essenza della donna è di essere minacciata, a volte dai genitori, più spesso dall’uomo; in ambedue i casi il matrimonio giuridico è la salvezza, la soluzione della crisi; che l’uomo sia adultero o seduttore (minaccia del resto ambigua) o refrattario, la panacea è il matrimonio come contratto sociale di appropriazione.” (Barthes, 1994: p.123)
Così, secondo Barthes, quali che ne siano le contraddizioni apparenti, questa morale non postula mai per la donna altra condizione se non parassitaria: solo il matrimonio, definendola giuridicamente, la fa esistere. Si ritrova qui la struttura stessa del gineceo, definito come una libertà chiusa sotto lo sguardo esterno dell’uomo. La Piccola Posta più solidamente che mai fissa la Donna come specie zoologica particolare, colonia di parassiti fornita di propri movimenti interni la cui debole ampiezza però è sempre ricondotta alla fissità dell’elemento tutore (il vir). Tale parassitismo, mantenuto sotto gli squilli di tromba dell’Indipendenza Femminile, comporta naturalmente una totale incapacità a qualsiasi apertura sul mondo reale: sotto il riparo di una competenza i cui limiti sarebbero lealmente dichiarati, la consigliera rifiuta sempre di prendere posizione sui problemi che sembrino andare al di là delle funzioni proprie del cuore femminile; la franchezza si ferma pudicamente alle soglie del razzismo o della religione; e poiché in effetti essa costituisce qui un vaccino di utilità ben precisa, il suo ruolo è di favorire l’inoculazione di una morale conformista della soggezione: si localizza nella consigliera tutto il potenziale di emancipazione della specie femminile: in lei le donne sono libere per procura. La libertà apparente dei consigli dispensa dalla libertà reale dei comportamenti: si mostra di cedere un po’ sulla morale per tener duro con più fermezza sui dogmi costitutivi della società. A proposito dell’occupazione lavorativa femminile, Barthes compie un’ulteriore dettagliata analisi riferendosi ora al giornale francese “L’Echo de la mode”, ed in particolare ad una delle sue rubriche seguita dalla giornalista Berte Bernage che incarna il ruolo di consigliera delle lettrici. La morale apparente è che le ragazze possono, naturalmente, lavorare, a patto che si scelgano un lavoro come si deve; il dogma reale è che nessun lavoro può essere come si deve per loro, dal momento che il loro statuto naturale è di essere un parassita dell’uomo; così, in un primo tempo, si offre generosamente alle ragazze la possibilità di scegliere tra tutto ciò che alla fine verrà loro negato. La prima operazione di questo gioco di prestigio consiste nell’immaginare il lavoro della Donna nelle sue forme più irreali, nel concepire dei lavori-miraggio, che potranno essere sconsigliati senza alcuna fatica. Volete diventare delle star, fare le scrittrici, le modelle? Rifletteteci bene. Il lavoro viene così inglobato nelle grandi funzioni oniriche, il carattere sacro della diva, la potenza creativa dell’artista, la perfezione del corpo umano, insomma, tutto ciò che nella nostra società si pensa contraddica magicamente il lavoro, poiché, in questi casi, l’origine della funzione viene considerata un dono quasi divino. Cosa rimane allora alle donne che vogliono lavorare? Rimangono le “belle carriere”: farmacista, laboratorista, professoressa, infermiera. Tenendo conto che per le giovani lettrici dell’ “Echo de la mode” questi mestieri possono essere un po’ più realistici, anche l’ostacolo è descritto in modo più realistico: si tratta della lunghezza degli studi o del loro costo. A questo punto, non sembra esserci alcun tipo di occupazione da scegliere con indipendenza per una donna che in quegli anni voglia lavorare, ma qui vuole arrivare Barthes, quando dichiara che di vuoto in vuoto, di miraggio in impossibilità, alla donna non resta più nulla da fare. Se, in questo orizzonte professionale che continua ad indietreggiare, c’è un lavoro che continua a rimanere ben saldo, a brillare come il lavoro femminile per eccellenza, e che la nostra Consigliera raccomanda caldamente alle sue lettrici, si tratta di quello di collaboratrice domestica, altrimenti detto di donna tuttofare. Ci dicono che è un lavoro che è molto cambiato, intendendo con questo che probabilmente la domestica non viene più trattata come un animale o un mobile. I vantaggi? Li si valuta soppesando felicemente, con un metodo ben noto, l’aspetto materiale (nessuna preoccupazione per l’alloggio e il vitto) e quello spirituale (la devozione a una Famiglia). Perché, anche in questo caso, l’essenziale è che la Donna, di qualunque età, non abbandoni il suo stato di dipendenza, che resti un individuo incompiuto, complementare per essenza. Come un parassita migratore, mai sola, mai responsabile, ma sempre nutrita, si trasferisce di famiglia in famiglia, sempre chiusa in una casa, da ragazza quella dei genitori, quando diventa una donna quella del marito, e se rimane zitella, se non può fare in alcun altro modo, quella dei padroni. Finora sono state trattate le donne in genere, specialmente le donne comuni, me Barthes non manca di parlare nella sua opera anche di donne “speciali”, donne che fanno un tipo di vita che le porta a farsi conoscere, come la grande attrice Greta Garbo. Nello specifico, l’autore fa un’analisi di un film uscito nelle sale cinematografiche prima diegli anni in cui egli scrive, dal titolo “La Regina Cristina”, nel quale la Garbo offriva una specie di idea platonica della creatura, e ciò appunto spiega come il suo viso sia quasi asessuato, senza per questo essere equivoco. D’altra parte, dobbiamo tenere bene in mente che, ciò che dirà Barthes in riferimento alla Garbo, andrà a colpire solo il suo personaggio e la sua bellezza, e non la persona che ella è veramente. Secondo Barthes, il viso della Garbo rappresenta quel momento fragile in cui il cinema sta per estrarre una bellezza esistenziale da una bellezza essenziale, l’archetipo sta per inflettersi verso il fascino dei visi corruttibili, la chiarezza delle essenze carnali sta per far posto a una lirica della donna. Di un altro fenomeno connesso alla donna, lo strip-tease, Barthes analizza le principali componenti, ponendo questo mito in relazione al corpo femminile, e dicendo che lo strip-tease -almeno lo strip-tease parigino- poggia su una contraddizione: desessualizzare la donna nel momento stesso in cui la si spoglia. Si può dire perciò che si tratta in un certo senso di uno spettacolo della paura, o piuttosto del “fammi paura”, come se l’erotismo si arrestasse a una sorta di delizioso terrore di cui basta annunciare i segni rituali per provocare l’idea di sesso e insieme la sua esorcizzazione. In ogni caso, il semiologo riporta questo avvenimento alla realtà della donna di tutti i giorni, alla sua condizione “naturale”. Tutto ciò mira a porre la donna, sin dall’inizio, come oggetto travestito, anche in quanto il denudamento è relegato al rango di operazioni parassitarie. E’ chiaro il percorso che fa Barthes per analizzare questo evento che attiene alla sfera femminile: viene a riportare il modello della vita della donna comune a classificazioni di diversa natura. Egli infatti conclude parlando dello strip-tease come occupazione lavorativa, affermando che esso è assimilato a una carriera (esordienti, semiprofessioniste, professioniste), cioè all’esercizio onorato di una specializzazione (le stripteaseuses sono operaie qualificate). Da un’analisi finita di tutto il quadro descritto sopra, si evince che la donna negli anni ‘50 del Novecento, almeno da quello che risulta dall’analisi di Barthes dei miti d’oggi e di diverse riviste femminili francesi, gode di una situazione sociale e familiare di subordinazione quasi totale, ora nei confronti della famiglia di appartenenza, ora del lavoro, ora del marito o degli uomini in generale. Si deduce anche che ciò che viene letto nelle pagine delle riviste femminili, nelle loro rubriche ma anche nell’universo comunicativo in genere, non è altro che un riflesso della società di quegli anni. La pubblicità ed il costume influenzano la costruzione di ruoli sociali nella misura in cui le dinamiche sociali vanno a dominare i mezzi di comunicazione.
8 G. Dyer, Advertising as Communication, Routledge, London and New York, 1982.
9 Per una discussione più approfondita sulla sociosemiotica, sono interessanti il primo ed il secondo capitolo del testo: G. Marrone, Corpi sociali. Processi comunicativi e semiotica del testo, Einaudi, Torino, 2001.
10 Martineau è il padre fondatore degli studi sulla motivazione in pubblicità. Uno dei suoi testi più interessanti è: P.Martineau, Motivazioni e pubblicità, ETAS Kompass, 1964.
11 (Cfr. S. Traini,Corso di semiotica, dispense a.a.2000-2001,Università di Teramo,2001.)
12 A tal proposito si veda: F. Marciani e A. Zinna, Elementi di semiotica generativa, Esculapio, Bologna, 1991.
13 J. M. Floch, Semiotica, marketing e comunicazione. Dietro i segni le strategie, FrancoAngeli, Milano, 1992.
14 Sui prodotti come segno si può consultare: E.Dichter, Gli oggetti ci comprano, Ferro Edizioni, 1967.
15 R. Barthes, Mythologies, Éditions du Seuil, Paris, 1957(tra.it. Miti d’oggi, Torino, 1994).
16 D. Kellner, Media Culture, Routledge, New York, 1994.
17 Molte analisi sui testi di Barthes si possono trovare in: P.Fabbri e I. Pezzini( a c. di), Mitologie di Roland Barthes, Pratiche Editrice, Parma, 1986, che contiene inoltre un intervento interessante di Umberto Eco su Roland Barthes fatto al convegno di Reggio Emilia del 13-14 aprile 1984.
18 J. Baudrillard, Il sogno della merce, Lupetti & Co., Milano, 1987.
19 D. Hebdige, Hiding in the Light. On Images and Things, Commedia/Routledge, London, 1988 ( tra.it. La lambretta e il videoclip, E.D.T., Torino, 1991).