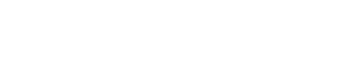Donna e pubblicità (3)
1.3 Conclusioni
Dall’esame dell’efficacia nella tutela della dignità della donna del sistema autodisciplinare si può desumere che l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, operante nella realtà Italiana da moltissimi anni, offre una copertura più ampia e meglio articolata di quanto potrebbe fare la legge dello Stato, a causa dei problemi di disorganicità dovuti al non coordinamento delle politiche in materia, rintracciabili da una prospettiva storico-giuridica. Gli organi dell’Istituto preposti, le procedure peculiari, la rapidità e la modalità di intervento sono tali da assicurare quella tempestività nella definizione dei casi, che risulta indispensabile nel mutevole campo della comunicazione pubblicitaria.
La qualità dei giudizi e la quantità degli interventi degli organi giudicanti costituiscono un serbatoio ricco e utile di cultura specialistica, prezioso patrimonio sia per gli operatori dell’autodisciplina sia per gli attori della pubblicità che intendano sviluppare un messaggio all’altezza del proprio ruolo e della propria marca.
Per quanto riguarda il ruolo della donna nella pubblicità, si continua a osservare un fenomeno che non incentiva un reale adeguamento del messaggio mediatico con i cambiamenti dei ruoli sociali.
I fattori che dovrebbero tenersi maggiormente in considerazione nell’ideazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria sono:
§ mostrare differenti modelli di donna che riflettano l’enorme diversità che esiste oggi nella reale definizione di ruoli e funzioni sociali;
§ portare maggiormente alla luce le situazioni che vive la donna sia all’interno della sfera privata e familiare, sia all’interno della sfera pubblica e lavorativa;
§ presentare la donna come protagonista delle proprie azioni e sostenitrice delle proprie idee, superando la lo stereotipo dell’essere vittime e subordinate al ruolo e al potere maschile.
La figura femminile che emerge (anche al di là delle pubblicità qui analizzate e precedentemente bloccate dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria a causa della violazione dei principi e degli articoli del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria) nei messaggi pubblicitari ha spesso la funzione di superare la crisi sociale dell’uomo in rapporto alla donna, la quale sceglie oggi con maggiore indipendenza la sua identità rispetto ai ruoli tradizionali del passato.
E’ vero che, per entrambe i sessi, non si è ancora in grado di fronteggiare l’ambivalenza legata da sempre all’immagine della donna, la quale rimane comunque il principale punto di riferimento della sicurezza e dell’affettività quasi scomparse, concretizzandosi nel possedere una propria identità separata e autonoma, che tuttavia non la rende ancora Individuo.
La scelta del modo di costruire un contenuto mediatico di solito si adegua ad una spinta propulsiva dovuta ad un cambiamento reale già avvenuto: solo in seguito otterrà l’investitura di oggetto di mutamento. Proprio per questo, il messaggio di una pubblicità non comunica quasi mai una reale scia di atteggiamento mentale o di comportamento da recepire, quanto piuttosto un superficiale prodotto di modernizzazione. I veri cambiamenti sociali non muovono dalla ricezione da parte dell’audience dei contenuti mediali, come li intendiamo oggi, ma non possiamo negare la grande influenza che essi esercitano sulla costruzione sociale del mito e dei ruoli e sulla collettività in genere. Per tutti questi motivi, è auspicabile che l’azione dello I.A.P. si espanda maggiormente di anno in anno, e che altre associazioni del mondo pubblicitario e di quello dei consumatori aderiscano alle iniziative e al Codice di questo Istituto, che al giorno d’oggi, in Italia, resta l’unico organo evidentemente in grado, per poteri e per organizzazione interna, di giudicare il contenuto e la validità di quei messaggi pubblicitari che, ogni giorno, ripetutamente ed incessantemente giungono nelle nostre case.
[1] Per l’inquadramento giuridico e la definizione di autodisciplina si veda: CRISCUOLO, L'autodisciplina.Autonomia privata e sistema delle fonti, Napoli, 2000.
[2] Questo orientamento è espresso chiaramente in: MINERVINI, ONADO, Efficienza dei sistemi finanziari e tutela del risparmio: disciplina o deregolamentazione?, in Regolazione e concorrenza, a cura di Tesauro e D'Alberti, Bologna, 2000.
[3] In quest’ottica l’autodisciplina pubblicitaria costituisce un sistema di tipo ordinamentale, dove il concetto di ordinamento: “implica dei rapporti, ma non si risolve in questi, anzi è a questi preordinato, nel senso che consiste in quella organizzazione o struttura che è necessaria perché i rapporti medesimi, se e quando si svolgono nella sua orbita, possano essere qualificati come giuridici”, SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico, Pisa, 1917. Secondo l’autore,infatti, l’autodisciplina crea una “superstruttura sociale” che domina i rapporti dei singoli e la loro posizione generica.
[4] FLORIDIA, Autodisciplina e funzione arbitrale, in Riv.dir.ind., 1991,pag. 5 ss. scrive che “il potere di autonomia privata si esercita diversamente a seconda che è diretto a regolare i rapporti intercorrenti tra soggetti determinati in relazione a singoli affari, oppure a regolare in modo generale e costante una serie indefinita di rapporti intercorrenti nell’ambito di categorie professionali in base a regole che promanano dalle stesse categorie interessate.
Nel primo caso il regolamento negoziale non aspira ad una funzione di supplenza rispetto ad una carente o insufficiente disciplina statuale, o, comunque, ad una funzione alternativa rispetto a quest’ultima, ma costituisce applicazione di una disciplina statuale – quella del negozio – che è preordinata allo scopo di consentire alle parti di dare volontariamente un assetto determinato ad un loro specifico rapporto.
Nel secondo caso, invece, il potere di autonomia si pone all’origine di una regolamentazione che crea vincoli di soggezione di natura diversa: un fenomeno para-normativo, del quale è stato detto giustamente che postula l’abbandono della idea secondo la quale nello Stato è collocata la fonte esclusiva delle norme giuridiche”.
[5] Per un esame dei problemi connessi con l’autodisciplina pubblicitaria si rimanda a : FUSI,TESTA, Diritto e pubblicità, Milano, 1996.
[6] Sul problema si rimanda, tra i più recenti, al contributo di: GRAZZINI, Autodisciplina e ordinamento statuale, Milano, 2003.
[7] Secondo questo primo orientamento basato sul presupposto della natura etica, l’autodisciplina pubblicitaria si configurerebbe come ordinamento separato e del tutto indipendente rispetto a quello statuale. Infatti essa produrrebbe principalmente effetti su un piano morale e pregiuridico.
In questa direzione si colloca: SORDELLI, Autodisciplina pubblicitaria: rapporti tra autodisciplina e legge statuale, in Riv.dir.ind., 1975, pag. 52 ss; il quale osserva che l’ordinamento autodisciplinare pubblicitario rappresenta “una forma di autodisciplina in quanto gli enti promotori hanno voluto ispirarsi a dei precetti etici e sociali, quindi pregiuridici, senza ancora entrare nel piano di quella che può definirsi autotutela, poiché in questo caso si suole far riferimento ad una forma di autodifesa che utilizza però in via autonoma taluni strumenti giuridici, ponendosi, dunque, dentro l’ambito dell’ordinamento giuridico”; ID., I problemi giuridici della pubblicità commerciale, Milano, 1968, pag. 239 ss.; ID., Contenuto delle regole di comportamento del codice di lealtà pubblicitaria, in Foro pad., 1974.
[8] Per un ulteriore approfondimento sul pensiero di questa fazione si rimanda a: GUGGINO, Considerazioni intorno alla natura giuridica dell’autodisciplina pubblicitaria, in Rass.dir.civ.,1989, pag. 331 ss.
[9] La conseguenza sta nel fatto che le norme dello Stato determinano ambito e limiti di efficacia dell’autoregolamentazione in ambito pubblicitario.In quest’ottica si pongono: BORRELLI, Autodisciplina pubblicitaria e leggi nazionali,in Riv.dir.ind.,1981, pag. 367-374; FUSI,TESTA, L’autodisciplina pubblicitaria in Italia, Milano, 1983. Per una rassegna sullo stesso tema si veda anche: PEDRIALI, Natura giuridica dell’autodisciplina pubblicitaria, in Dir.inf., 1994, pag. 597 ss.