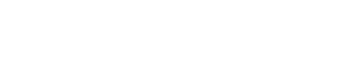Consultare il trascorso per valutarne la complessità.
Più che una riflessione voleva essere un proponimento: qualora fossi riuscito a definire e gestire un blog, mi sarei dedicato a sviluppare delle attente valutazioni sulle qualità specifiche dell’artigianato. Attribuendomi un merito che è tutto da ascrivere a «Comunitàzione, posso dare per risolta la possibilità d’uso dello strumento: «web log». Per quanto possibile, cercherò di avvalermi, potendone far parte, di quelle intelligenze individuali che usano il computer in maniera originale, interattiva e cooperativa, consentendo la circolazione in rete di informazioni eterogenee e che estendono le capacità cognitive. Dato per scontato l’atteggiamento riflessivo, mi prefiggo di consultare il trascorso per valutarne la complessità.
L’ambizione di coniugare « arte e industria» può essere vista come una costante della tradizione lombarda. Un elemento a lungo oscurato dal mito della Milano industriale del Novecento, che spiega, tuttavia, il successo della tradizione mobiliera della Brianza, della liuteria artistica cremonese, delle ceramiche «Vecchia Lodi» e di altri centri di eccellenza lombardi. Queste attività, pur dinanzi a molte difficoltà e a sfide sempre più pressanti, dimostrano che la cultura del prodotto realizzato «a regola d’arte», con abilità consolidata e invenzione geniale, continua ad avere un promettente futuro.[1] L’intento è di farne apprezzare e sfruttare la dimensione creativa artigianale, che tanto ha sorpreso l'umanità per serietà e perfezione, per lo sviluppo di una struttura sociale. Entrare nel mondo dell’artigianato, è scoprire un fenomeno tanto complesso che supera in importanza quello che a prima vista è la finalità dell’opera realizzata. «In un oggetto artigianale si fondono ed interagiscono varie componenti: l’utilità, la necessità economica, l’espressione artistica, la realizzazione personale, la motivazione religiosa».[2]
Una simile esercitazione non può prescindere dalle reminiscenze del proprio passato, sia come ragazzo di bottega sia come quadro: dipendente preposto alla gestione di cantieri. Correvano gli anni ‘50: il doposcuola consisteva in una sorta di apprendistato presso un’officina artigianale. Di quel tempo mi è rimasto impressa l'antica bottega dove il fabbro si accaniva con il ferro lavorato a mano: scaldato nella fucina a carbone, battuto sull’incudine, modellato con strumenti manuali. Non era utilizzato alcun pezzo prestampato: si realizzava ogni lavoro partendo dal tondino o dal quadrello di ferro e l’assemblaggio dei pezzi così creati era eseguito con fascette, chiodi ed incastri. Della forgia che funzionava con il mantice a pedale, io ne ero l'operatore a tempo pieno. Spiccava l'elevata professionalità del fabbro che esercitava il mestiere con altissima qualità: da qui, probabilmente, il termine di «ferro battuto» che tutt'oggi si usa comunemente per descrivere un «manufatto lavorato ad arte». Gli altiforni a carbone della «rivoluzione industriale», ed in seguito i laminatoi, hanno reso disponibili barre di ferro di svariate dimensioni ad un costo accessibile. I forni a colata continua a ciclo integrale e le moderne tecnologie di taglio e saldatura, hanno abbattuto ogni limite alla lavorazione del ferro. Cominciava a profilarsi una società industriale fondata su di una specifica e socialmente condivisa visione del mondo: una visione del mondo nata per comprendere, progettare e far funzionare sistemi “semplici”, sistemi caratterizzati da parti che svolgevano funzioni specifiche e che devono essere eterodiretti[3].
Ora accade che questo modello di società, i suoi attori, i suoi sistemi la sua visione del mondo, sta perdendo di significato, causando disaggio profondo, incertezze e pessimismo. In tanti si sta cercando di predisporre un’alternativa, che stenta a coagularsi, di un nuovo modello di società[4]. L’idea di «scatenare un nuovo Rinascimento», induce alla riconsiderazione della capacità di capire, lo sviluppo culturale e personale e la consapevolezza, nell'agire quotidiano. Il riferimento alla realtà artigianale, per tentare di sviluppare, con il grado di compiutezza possibile, l'interazione tra l’uomo, l’ambiente, la società e la natura, parrebbe sostenibile.
Buonsenso vuole che si rifugga dall’auto referenza, ma trovo oltremodo stimolante ricondurmi anche all’esperienza iniziata con la maturità. Un bagaglio di conoscenza, concretato in oltre trenta anni d’ininterrotta attività operativa: una funzione esercitata, in un contesto organizzativo di gruppo orientato alla realizzazione, il cui punto di forza è costituito nel saper assimilare il piano di lavoro e nel coordinare la pratica dei mestieri. Una pratica che si armonizza con il progetto, si evolve nel procedere e si diffonde nei gruppi di lavoro come conoscenza implicita. In sostanza la pratica di gestione, la buona pratica: sapere come, per gli inglesi «know how» e sapere che, per gli inglesi «know that», il primo fondato sull'esperienza ed il secondo su regole e procedure operative. Ciò che emerge in modo sempre più evidente e profondo è il cambiamento che sta avvenendo nel nostro approccio con la conoscenza e con il sapere, strettamente legati allo sviluppo degli strumenti che attualmente permettono il loro raggiungimento.
Quando di un lavoro si dice «fatto a regola d'arte» di solito si pensa ad un prodotto fatto bene, ad un manufatto che segue antiche regole precise. Per fortuna è un modo di dire anche oggi sostenuto dalle buone pratiche e da quella sostanza che è il lavoro artigianale. Riaccostarsi a queste tradizioni può rilanciare e rinnovare inclinazioni e vocazioni, individuali e sociali, per meglio relazionarsi e gettare ponti di collegamento importanti con la pratica politica curando la formazione intellettuale che possa collegare strutture ed imprese attorno ad una riflessione sui processi di modernizzazione.
[1] da Paolo Colombo. Contributi per una definizione del mestiere d’arte (Vita e Pensiero, Milano 2000).
[2] http://www.ilcannocchiale.it/blogs/style/writer/dettaglio.asp?id_blog=2290
[3] Un famoso libro americano, pubblicato nel '50, e ripubblicato più volte e in più traduzioni – La follia solitaria di David Riesman - introduce con successo le locuzioni autodiretti ed eterodiretti per indicare sinteticamente chi è capace di autonome scelte e chi invece appartiene alla schiera di questi flessibili conformisti. Considerati da un punto di vista dinamico di sviluppi bene o male riusciti, questi due termini in fondo esprimono già una variabile consequenzialità possibile di 'cause' ed 'effetti': non sono cioè esatti sinonimi di definitivi, statici 'leader' o 'gregari', 'egemoni' o 'subalterni', o - in un'ottica più mobile - di ostili vincenti o perdenti..
Non so poi se l'essere autodiretti o eterodiretti sia una caratteristica genetica o acquisita, forse entrambe (mi ricorda un po' la distinzione tra leader e gregari). La tristezza a me viene dal riconoscere di vivere (per ora) tra i gregari eterodiretti - e quindi non vivere . Di fare difficoltà ad ammetterlo e di non avere gli strumenti per modificare subito la mia condizione. Capisco anche che non si può modificare subito, che la trasformazione e la crescita richiedono un tempo.
[4] Un popolo di poeti santi e navigatori che genera un nuovo rinascimento di Francesco Zanotti http://www.sapereperfare.it/articolo.php?id=321#