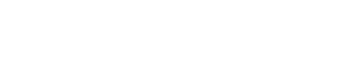Sicurezza sul lavoro: urge azione per eliminare rischi.
«Un piano straordinario, condiviso tra Stato, Regioni, Sindacati e Imprese. Un piano teso a prevenire gli infortuni sul lavoro di origine comportamentale». L'approccio per arginare il fenomeno delle morti bianche deve procedere «per obiettivi, come diceva Marco Biagi, non solo per regole» poiché «le regole servono e vanno sostenute dalle sanzioni ma ulteriori adempimenti e sanzioni possono anche produrre l'effetto opposto». La proposta contenuta nel Piano presentato il 12 giugno alla platea dell'assemblea di Confartigianato, «investe invece in prevenzione, formazione e informazione», considerate dal titolare del Welfare le leve più efficaci per favorire comportamenti corretti nei luoghi di lavoro.
Il comportamento è il modo di agire e reagire di un oggetto o un organismo messo in relazione con altri oggetti, organismi, o semplicemente con l’ambiente. Il comportamento può essere conscio o inconscio e volontario o involontario. Il comportamento umano, cosi come quello di altri organismi, può essere comune, insolito, accettabile o inaccettabile. Gli uomini valutano l’accettabilità di un determinato comportamento usando norme sociali e regolando i comportamenti tramite mezzi di controllo sociale.
Scartando a priori l'eventualità che una trasgressione od omissione possa discendere da un atto volontario e cosciente, ciò che interessa in questa sede è la distinzione tra comportamento corretto ed errore involontario. La distinzione è chiara ma la differenza non è altrettanto percettibile perché l'errore involontario non sempre dà luogo a conseguenze negative, mentre, al contrario, in certe particolari condizioni, anche un intervento umano perfettamente a norma può causare eventi imprevedibili per accidentali interferenze con impreviste incompatibilità ambientali o tecnologiche. Un’adeguata preparazione del fattore umano deve avere anche lo scopo di rendere accettabili norme di comportamento presentate per quello che sono e cioè il prodotto di una conoscenza approfondita del rischio e non vengano sopportata invece come un obbligo imposto dall’organizzazione lavorativa ed avvertite come “estranee” o comunque “esterne” all’interesse dell’operatore.
La comunicazione.
Secondoil filosofo americano Pearce (1989)[1] la comunicazione è il processo attraverso il quale le persone creano e gestiscono la realtà sociale coordinandosi tra loro: attraverso la comunicazione gli individui costruiscono i significati e gestiscono i significati creati attraverso questo processo. La comunicazione diventa così il processo primario attraverso il quale si costruisce la realtà sociale e questo processo si articola in una sequenza continua di gestione, interpretazione e costruzione dei significati da parte dei partners. Ogni azione viene interpretata sulla base di regole costruttive che divengono le condizioni antecedenti per una nuova azione. In questo modo la comunicazione viene “imbrigliata” e incanalata da processi che prefigurano la comunicazione stessa ma allo stesso tempo viene sottoposta a forze che operano per una modificazione dei significati. Ci troviamo così di fronte ad un processo dinamico che si articola attorno ad una lotta per il cambiamento e per il mantenimento dei significati. In questo processo continuo di conservazione e mutamento diventano importanti la coerenza ed il coordinamento che vengono prodotti nella comunicazione.
Perché lavoriamo?
D’acchito viene da dire che lavoriamo per adempiere il principio fondamentale della nostra costituzione: art.1 l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Compiuto l’adempimento, da cittadino italiano essere in predicato per poter godere di pari dignità sociale: art.3 della costituzione medesima. Il lavoro è un’attività produttiva esplicata con l’esercizio di un mestiere, una professione ed ha come scopo la soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi.
Qual è il significato del lavoro?
Lavorare significa occupare il tempo nel fare qualcosa, traendone un vantaggio economico. Infatti, con il termine occupato si definisce lo status di lavoratore, e con il suo opposto, disoccupato, si definisce lo status – in verità poco voluto – di chi non ha lavoro. L’etimologia del termine lavoro riporta al latino labor con significato di fatica. Sono noti i detti della letteratura classica durar fatica e operar faticando. Ancora oggi in alcuni dialetti si utilizzano i termini faticare, andare a faticare, per intendere lavorare e andare a lavorare. Altro termine dialettale sinonimo è travaglio.
A questo punto vale la pena retrocedere nella storia della filosofia, fino a quando la professione è diventata una componente essenziale della personalità. In proposito riprendiamo Gebaur[2] che cosi risponde alla stessa domanda: «…se si segue per esempio Max Weber, ci si imbatte nell’etica protestante , questa concezione della professione basata sull’etica, inizialmente è stata il motivo di vita basilare (soprattutto per alcune sette protestanti), per poi diventare un aspetto tipico del mondo contemporaneo - ascetico, razionale, sistematico - e sempre compreso nel cosiddetto involucro del mestiere. Proprio per via di questa concezione, nel corso del XVII e del XVIII secolo la professione si è trasformata in un aspetto importante. Già allora, Weber è partito dal concetto che ciò potesse trasformarsi in un modello basilare per il mondo moderno – e ha sicuramente avuto ragione[3]. A partire dal XIX secolo, il significato della professione è indiscusso, quantomeno in paesi come la Germania. La seconda radice importante per i tempi moderni è stata probabilmente l’interpretazione del lavoro da parte dell’idealismo tedesco: comprensibile, se si considera che il lavoro non avesse un’accezione particolarmente positiva prima di esso e che per definirlo, si adottavano solitamente termini come „servitù“, „obbligo“ o „fatica“». Allora non lavoravano ancora tutte le fasce della società e il lavoro non era considerato particolarmente bene. E ancora Gebaur«Nella filosofia, esso assume un valore particolare con Hegel, che propone una rappresentazione estremamente positiva del lavoro (soprattutto quello non manuale). Il concetto di lavoro fu utilizzato per descrivere la produzione dell’essere umano sulla base della sua spiritualità. Il primo passo fondamentale è stato l’acquisizione dell’autoconsapevolezza attraverso il lavoro: questa, per esempio, è anche la considerazione del filosofo tedesco Fichte. Ci si riferisce concretamente alla quotidianità di esso e all’affermazione contro le difficoltà del mondo e viene subito concepito empaticamente come „autocompimento“ dell’essere umano. E’ interessante rilevare che il lavoro a quel punto guadagna tutte le caratteristiche precedentemente attribuite da Schiller al gioco[4]».
Come deve essere organizzato il lavoro?
Le Relazioni Umane vennero definite «il taylorismo dal volto umano». Malgrado certe idee fossero state largamente divulgate, la loro penetrazione fu appena superficiale. Era necessario un nuovo tipo di capo, qualcuno che avesse alla base delle proprie motivazioni personali, più che il piacere di comandare gli altri individui, il desiderio di favorire le produttività di gruppo. Sfortunatamente il fatto di avere potere sugli altri è spesso un'esperienza troppo affascinante per chi la possiede: solo un individuo con notevole autocontrollo può cedere una parte di potere deliberatamente. Se da un lato le teorie tayloriste avevano pressoché ignorato il ruolo del fattore umano nell'azienda, dall'altro la scuola delle relazioni umane l'aveva eccessivamente enfatizzato, facendone l'elemento prevalente dell'organizzazione e trascurando altri elementi essenziali. Sotto questo profilo, la teoria sistemica si propone come innovativa in quanto inserisce il fattore umano tra gli altri elementi che determinano le caratteristiche e il funzionamento dell'organizzazione.