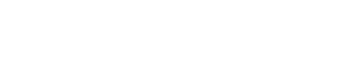Udine e Bilancio Partecipativo: una sfida vincente
La città di Udine ha appena concluso la sua prima esperienza di bilancio partecipativo: un progetto sviluppato nell'arco di pochi mesi, attraverso pubbliche assemblee di quartiere, che ha visto l'Amministrazione Comunale assumere il ruolo di interlocutore squisitamente tecnico e di mero accompagnatore; mentre il protagonista principe non poteva che essere lui: il Cittadino.
L’esperienza udinese è la prima della Regione Friuli Venezia Giulia, ma molti enti locali italiani stanno avviandosi verso la strada dei processi di partecipazione popolare, tant'è che oggi l’argomento assume dimensioni nazionali interessanti.
Questa nuova formula di decisionismo democratico, si aggiunge e si confonde con un sistema di governo tutto fondato sulla democrazia rappresentativa: e su questo è doverosa una preliminare riflessione, se non altro per l’apparente anomalia di coniugare due formule che, ancorché si presentano sotto il comune denominatore della democrazia, si risolvono, poi, di fatto, in due sistemi di governo assolutamente differenti.
Ci si chiede, inoltre, quali siano le cause che hanno costruito (o almeno accelerato) nell’arco di brevissimo tempo, un cambiamento socio-istituzionale di cui ancora non realizziamo, fino in fondo, la portata.
Il dubbio che un sistema di governo fondato sulla democrazia rappresentativa possa convivere con decisioni assunte direttamente dal popolo (in quanto ad esso “ri-delegate” in nome della sua sovranità), sorge sulla base della constatazione che tra democrazia diretta e regime rappresentativo, si è, da sempre, tracciata una nettissima linea di demarcazione, stante la radicale differenza che le separa.
Ma se il concetto di democrazia diretta è ancora oggi quello insegnatoci dagli autori classici, (cioè quello della manifestazione di volontà del “popolo adunato”), è pur vero che in questa società complessa ogni tecnica decisionale comporta, oggi, una mediazione. E di questo, anche nei processi di bilancio partecipativo non può non tenersi conto. Mi spiego. Una interposizione fra popolo e decisione politica, anche qualora quella decisione venga imputata al popolo stesso (e quindi alla sua “diretta” manifestazione di volontà), è inevitabile: la realtà quotidiana dimostra, infatti, come l’opinione pubblica si forma (ancora) anche attraverso la mediazione dell’attività di gruppi e partiti politici; né può trascurarsi la grande influenza dei mezzi di informazione che, spesse volte, prevaricano l'ideologia degli stessi gruppi e partiti politici (quelli più deboli).
Per questo, allorchè si tratti il tema del Bilancio partecipativo, sarebbe più adeguato l'uso del termine “democrazia partecipativa”, in luogo di quello di democrazia diretta, pur nella consapevolezza che il Bilancio Partecipativo presenta specifici connotati che superano il significato proprio del termine “partecipazione” a cui spesso si fa riferimento in relazione agli istituti costituzionali del referendum abrogativo e della partecipazione popolare.
Non v’è dubbio, poi, che l’avvio dei processi partecipativi trovi la propria causa e ragion d’essere nella crisi che ormai da tempo vive la nostra democrazia rappresentativa.
Di partecipazione si discute nel dibattito politico italiano a partire dagli anni ‘60: sono gli anni dei consigli di fabbrica, dei consigli scolastici, delle prime esperienze di urbanistica partecipata (in verità, più nella formula della consultazione che non della vera e propria “partecipazione”, nel senso qui inteso) che, nel decennio successivo, danno avvio alla legislazione della materia.
Con gli anni ’90 iniziano a differenziarsi gli statuti comunali (soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge istitutiva dell’elezione diretta del sindaco), e si rafforza, con il Testo Unico degli Enti Locali del 2000, il ruolo degli enti locali, quali istituzioni più vicine al cittadino.
E' allora che nasce l’esigenza di individuare specifici strumenti, capaci di adattarsi ai diversi contesti locali, con l’obiettivo di trasformare la partecipazione, fino ad allora "simbolica", in vera e propria risorsa strumentale.
In questo contesto due fondamentali fattori hanno concorso all’eccelerazione del processo Bilancio partecipativo:
1) - l'ampliarsi del principio di sussidiaretà.
Principio per il quale la decisione va presa nel luogo più vicino al popolo. Il principio ha di fatto creato una sorta di catena di de-responsabilizzazioni progressive, in un sistema dalle caratteristiche piuttosto asimmetriche: da un lato, infatti, viviamo in piena epoca di globalizzazione dei problemi; dall’altro, assistiamo ad una sempre più pregnante "localizzazione" delle soluzioni, che carica le amministrazioni locali dell’intera responsabilità delle scelte (ma a cui, peraltro, non sempre seguono adeguati trasferimenti di risorse, indispensabili per farvi fronte).
Infine, la riforma del Titolo V della Costituzione chiude questo percorso verso i nuovi principi di sussidiarietà innalzando a livello costituzionale la stessa valorizzazione dell’autonomia degli enti locali (art. 118 Cost.) che porta alla previsione di nuovi modelli organizzativi e di relazione tra amministrazione e cittadini, fondati sulla comunicazione e sulla co-decisione.
Questa crescita del decisionismo istituzionale locale ha portato a sua volta a creare sempre più di spazi di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni pubbliche: un coinvolgimento che le istituzioni stesse hanno ritenuto indispensabile, per rendere ‘sostenibile’ la Politica davanti alle continue crisi di legittimazione dell’ultimo ventennio.
2) - la crisi del sistema dei partiti politici.
Già Carlo Esposito, giurista e filosofo del secolo scorso, aveva avuto modo di affermare che, se un partito invece di rappresentare una ideologia e tendere al bene comune rappresentasse le esigenze di un gruppo di pressione economico, sarebbe di fatto un gruppo di pressione mascherato, e sarebbe per questo da combattere, da espellere dal Parlamento, da denunciare come scandaloso”
Il giurista già allora precisava che la proiezione pubblica del partito, in quanto strumento di raccordo tra Stato e società civile con l'esclusiva funzione pubblica di trasmettere la volontà sovrana del popolo, non sarebbe compatibile con l’inquinamento della politica da parte di interessi personali ed economici.
Ed in effetti, l'inquinamento della politica con interessi di parte, ha avviato ad una crisi del sistema che ha, in questi anni, amplificato il senso di diffidenza e di sfiducia del popolo sovrano che si è poi riversato sulle istituzioni, nucleo e fondamento della democrazia rappresentativa.
Se, quindi, i partiti sono chiamati a assolvere a una “funzione basilare nella vita della nostra democrazia rappresentativa”, ecco che, la crisi che oggi essi vivono si traduce e confonde con la stessa crisi della democrazia rappresentativa: da qui la naturale conseguenza della necessità di ricerca di nuove soluzioni.
E' in questo contesto che in Italia si inizia a conoscere il tema del Bilancio Partecipativo, grazie ad alcuni studi universitari sull’argomento avviati dal 1998.
Le molteplici esperienze di Bilancio Partecipativo portate avanti in questi anni da vari enti locali dimostrano oggi l'elevato grado di maturità pubblica, che risolve il processo nella realizzazione di uno strumento capace di mettere in relazione amministrazioni, cittadinanza e apparato burocratico, per migliorare, in ultima analisi, la gestione del territorio.
Le varie sperimentazioni costituiscono perciò un percorso di estrema importanza, sopratutto guardando all’Italia, dove il dibattito si è sviluppato in parallelo a quello sui Bilanci Sociali (diretti a misurare gli effetti sociali delle politiche pubbliche) e ha trovato terreno fertile per essere compreso in tutto il suo ruolo di strumento di comunicazione volto al rinnovamento politico, centrale per l’arricchimento dell’autoconsapevolezza e del senso civico di cittadino.
L'esperienza di Udine, favorita e anticipata dalla partecipazione alla Rete 9^ del Progetto europeo UR-BAL e successivamente dalla decisione consiliare di associarsi alla Rete del Nuovo Municipio, risulta centrata, in particolare, sull’idea di portare avanti una “autoeducazione alla democrazia della cittadinanza”, attraverso forme di co-decisione tra abitanti ed istituzioni relativamente ai nuovi investimenti per il territorio.
In tal senso Udine ha promosso e realizzato un'esperienza di coinvolgimento della cittadinanza che presenta tutte le caratteristiche tecniche per potersi tradurre in un percorso strutturato, dove i cittadini sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella costruzione delle decisioni.
In tale prospettiva, Udine assume oggi il ruolo e la funzione di "apripista" nell'ambito dell'intero territorio regionale, dove processi di Bilancio partecipativo e progetti di Bilancio Sociale, hanno ancora molta strada da percorrere.