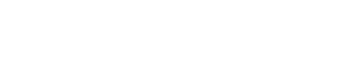Una qualità che ci rendeva speciali e migliori.
Stressato da una discutibile gestione condominiale: sterili dibattiti col tentativo di disquisire su argomenti per un certo verso impegnativi: appalti, subappalti, insolvenze, deficienze ecc… andati a sfociare nella polemica sulla linea di comportamento di chi amministra - sia comune, sia condominio -.
Un’apprensiva riservatezza mi ha portato a riconsiderare l’atteggiamento provocatorio, caratterizzato da una certa esperienza nella «gestione d’impresa». Continuo a rilevare esecrabili comportamenti di gestione del condominio che vanno dalla costrizione a rimanere con l’ascensore impedito all’uso per quindici giorni, alle iniziative più disparate nell’amministrazione con un agire dissennato senza tenere conto delle delibere delle assemblee documentate.
Estenuato per il fatto stesso di non saper trovare via d’uscita o riferimento alcuno, (paradossale ma comune l’alternarsi di più amministratori) cerco conforto con un singolare passatempo: la lettura. Una stravagante circostanza mi porta a comparare una pagina del libro sottomano «L’Italia non esiste» di F. Rondolino che riporto integralmente con una sola interruzione.
La ragione di questo fallimento sta nell’ideologia italiana: cioè nel rifiuto, esplicito o implicito, dissimulato o esibito, della modernità e delle sue categorie economiche, sociali, culturali e politiche. (…) Fra i tanti paradossi della nostra storia patria, c’è anche questo: che gli stati italiani di primo Ottocento avevano avviato, seppur in maniera tutt’altro che omogenea, un loro processo d’industrializzazione e di modernizzazione. Il caso forse più eclatante (perché il meno conosciuto) riguarda l’abitualmente deprecato Regno borbonico.
Nel 1856, il Regno delle due Sicilie fu premiato all’Esposizione Internazionale di Parigi come terzo stato più industrializzato d’Europa. Fra i vanti del Regno, la prima nave a vapore del Mediterraneo (1818), costruita nel cantiere di Stanislao Filosa al ponte di Vigliena presso Napoli, e, nel 1839, la prima linea ferroviaria italiana, tra Napoli e Portici (al tempo dell’unità d’Italia la tratta era giunta a Eboli). E ancora: il primo ponte sospeso in ferro dell’Europa continentale (1832), la prima illuminazione a gas in Italia (1839), il primo osservatorio vulcanico del mondo, sul Vesuvio (1841). L’anno prima era stata inaugurata la fabbrica metal meccanica di Pietrarsa, cui si affiancava una scuola per macchinisti ferroviari e navali, grazie alla quale il Regno poté sostituire, nel giro di pochi anni, le maestranze inglesi utilizzate in precedenza.
I Savoia incamerarono nelle esauste casse piemontesi, divenute italiane, i 443 milioni di ducati-oro che giacevano nel Banco nazionale delle Due Sicilie (pari a due terzi del patrimonio di tutti gli stati preunitari messi insieme), e cominciò così la «questione meridionale».
È Vincenzo Cuoco l’«inventore – scopritore» (secondo le parole del Bollati) di un'Italia che trae salute e vigore dalle radici profonde dalla sua antica civiltà contadina, un’Italia anti-intellettualista sdegnosa dei decadenti raffinamenti culturali dell’età moderna, fiera di una sua nobiltà autoctona, di un suo primigenio costume morale.
L’Italia non esiste (pgg.52 / 53)