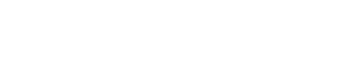Spigolature di cultura.
L’annosa questione dello «scontro» tra le due culture ha, in Italia, un punto critico particolare nell’insegnamento scolastico, almeno dalla riforma Gentile (1923). Mentre l’insegnamento delle discipline umanistiche si basa su di una forte struttura storica che regge e inquadra la didattica, quello delle discipline scientifiche è offerto come un insieme di verità atemporali. Più che il metodo scientifico, la scuola italiana trasmette «ricette» estranee alla situazione storica e sociale.
Difficilmente la scuola offre percorsi di conoscenze proprie di diverse discipline che possano mostrare agli studenti l’unità della cultura e i continui travasi che caratterizzano l’evoluzione o l’involuzione del pensiero. Gli stessi studenti si trovano poi ad affrontare i corsi universitari dall’una o dall’altra parte di questa ideale «barricata», con il rischio di un impoverimento generale della cultura del nostro paese. Contestualizzazione e interdisciplinarietà possono invece essere offerte come chiave per aprire agli studenti una diversa visione che investe le stesse materie umanistiche, lette nei loro rapporti vivi con la scienza contemporanea. Con un’avvertenza: alla divaricazione delle due culture contribuisce anche la distorsione che l’idea scientifica subisce nel travaso verso altri campi del sapere.
Si tratta tuttavia di un meccanismo di comunicazione utile per ragionare sui processi, i canali e gli stili della divulgazione scientifica, e sulla ricezione del messaggio nella società. Verso la fine dell’Ottocento molti scienziati ritenevano che la maggior parte delle leggi che regolano i fenomeni fisici fossero stati scoperti. In particolare sostenevano che tutti i moti conosciuti potevano essere studiati attraverso l’applicazione delle leggi di Newton e che tutti i fenomeni elettromagnetici erano ampiamente descritti dalle leggi di Maxwell. Il 25 marzo 1915 Albert Einstein presentò ufficialmente la teoria della relatività: una data che ha cambiato il corso della storia, imprimendo una svolta nella ricerca scientifica.
È un evento che si ricorda «relativamente» poco, rispetto ad altre date importanti per la storia del Novecento, forse per la difficoltà di spiegare a un pubblico non specialistico in cosa consista la teoria della relatività. La ragione per cui di solito soltanto il nome di Einstein è legato alla relatività è che il suo lavoro del 1905 non rappresentò che il punto di partenza per l’ancor più fondamentale «relatività generale», nella quale egli enunciava una nuova teoria della gravitazione aprendo nuove prospettive alla comprensione della struttura dell’Universo. Di lì a pochi anni, infatti, il fisico statunitense Edwin Hubble arrivò alla formulazione della teoria inflazionaria: fu la scoperta dell’espansione dell’Universo, avvenuta circa duemila anni dopo che il poeta Lucrezio scriveva proprio dell’infinità dell’Universo nel suo poema didascalico-filosofico De rerum natura.
La riflessione del filosofo ebbe un impatto notevole sulla cultura e sulle arti visive in particolare. Infatti, l’irruzione della dimensione temporale nello spazio della pittura è un elemento di poetica che accomuna in pratica tutte le avanguardie d’inizio secolo, il cubismo e il Futurismo in primo luogo: la prima, volta a una più completa rappresentazione dell’oggetto attraverso molteplici punti di vista; la seconda, legata ad un insolito tentativo di figurazione pittorica della «quarta dimensione», il tempo. La scienza, «spazializzando» il tempo, lo snatura; inaspettatamente, però, la pittura si rivela in grado di ribaltare questo rapporto: attraverso una deformazione delle immagini spaziali, essa inventa l’effetto visivo di un tempo «vivo».
In un’Italia angusta, provinciale, stoltamente convinta di poter fare parte delle grandi potenze; in un paese dove l’industria era concentrata solo al Nord e l’agricoltura era in crisi; in un contesto culturale disuguale e ambiguo; in una realtà così incerta e contraddittoria lo scrittore italiano Luigi Pirandello, uno dei massimi drammaturghi del Novecento, in linea con tutta la coeva filosofia irrazionalistica, elaborò una sua visione frantumata dell’individuo e riuscì a conquistare con le sue opere quella statura internazionale che nel 1934 gli fu ufficialmente riconosciuta con l’assegnazione del Premio Nobel.
Dal vitalismo pirandelliano scaturiscono importanti conseguenze sul piano conoscitivo: se la realtà è in perpetuo divenire, essa non si può fissare in schemi e moduli d’ordine totalizzanti ed onnicomprensivi. Non solo, ma non esiste neanche una prospettiva privilegiata da cui osservare l’irreale: le prospettive possibili sono infiniti e tutti equivalenti.
Ciò comporta un radicale relativismo conoscitivo: ognuno ha la sua verità, che nasce dal suo modo soggettivo di vedere le cose. Da ciò deriva un’inevitabile incomunicabilità tra gli uomini, poiché ciascuno fa riferimento alla realtà come gli appare, mentre non può sapere come sia per gli altri. Nulla ebbe, dunque, tanti risvolti culturali e determinò così numerose speculazioni intellettuali nel Novecento quanto la formulazione della teoria della relatività di Einstein: le sue scoperte hanno avuto un impatto rivoluzionario, i suoi effetti sono visibili ancora oggi nella fisica, ma anche in tanti aspetti della nostra vita quotidiana.