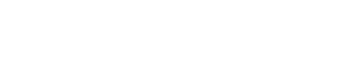La dodicesima edizione di Parolario, il Festival letterario a Como.
Dal prossimo 30 agosto al 9 settembre sarà proposto alla città e ai cittadini, su un’idea degli architetti di Como condivisa con i principali enti e istituzioni, un particolare itinerario di progetto urbano che ci piace chiamare «La città della cultura». I paesaggi delle città non sono muti, raccontano conoscenze, storie ed emozioni, in una parola parlano della memoria collettiva. E’ dunque ascoltando il passato, sapendo leggere le tracce e i segni tramandati, che si può meglio disegnare il futuro. L’itinerario architettonico-letterario si snoderà lungo un percorso a un tempo fisico e ‘ideale’, e inviterà a una riflessione progettuale, il cui elemento catalizzatore è il patrimonio razionalista del ‘900.
Questa rete di luoghi, che comprende la Casa del Fascio (o meglio l’Isola del Razionalismo, ossia Casa del Fascio ed ex U.L.I.), il lungo lago, i giardini, lo stadio, la proto-città razionalista, la passeggiata Gelpi, Villa Olmo, sino ad aprirsi ed essere alimentato dall’idea anticipatrice del kilometro della Conoscenza, costituisce una straordinaria sedimentazione della storia in grado di dare risposte all’apparato museale, ricreativo, conoscitivo indispensabile per una città che cerchi di affermare la propria identità.
Quasi un obbligo per un luogo così ricco di storia, di percorsi architettonici unici. Quello razionalista, che negli anni ’30 a Como ha avuto un’occasione di sviluppo sicuramente più importante che altrove. Significativa la coincidenza con la dodicesima edizione di Parolario, il Festival letterario che avrà come tema «Leggere il futuro». Uno sguardo attraverso molteplici temi: la filosofia, la poesia, lo sviluppo sostenibile, la cultura del cibo, gli orizzonti futuri del nuovo mondo globale, per immaginare cosa ci attende, cosa possiamo sperare, e cosa dobbiamo cominciare a costruire.
Calzante, qualora potesse avverarsi, uno sguardo sulla stratificazione sociale: termine mutuato dalla geologia, dove s’indica la modalità di formazione di alcune rocce, introdotto per la prima volta da Pitirim Alexandrovich Sorokin nel suo studio sulla mobilità sociale (La mobilità sociale, 1927) per designare «la differenziazione di una data popolazione in classi gerarchicamente sovrapposte» in conformità a «una distribuzione diseguale di diritti e privilegi, doveri e responsabilità, di valori sociali e privazioni, di potere sociale e d’influenze, tra i membri di una società».
La stratificazione non è un fattore universale, se non inteso come una naturale misura adottata dalle classi dominanti per mantenere lo status quo contro le classi inferiori entrambe in un continuo conflitto. Accanto alla gerarchia di classe, su base economica, esistono quella di appartenenza politica, fondata sul potere, e quella di ceto, legata alla cultura. Recenti pubblicazioni si sono concentrate sul passaggio dalla modernità al post modernità e le questioni etiche relative. È stato paragonato il concetto di modernità e post modernità rispettivamente allo stato solido e liquido della società. Si è tentato di spiegare la «post modernità» usando le metafore di modernità «liquida» e «solida». Si è sostenuto che l'incertezza che attanaglia la società moderna deriva dalla trasformazione dei suoi protagonisti da produttori a consumatori.
Lo smantellamento delle sicurezze a una vita «liquida» sempre più frenetica e costretta ad adeguarsi alle attitudini del «gruppo» per non sentirsi esclusa. L'esclusione sociale elaborata non si basa più sull'estraneità al sistema produttivo o sul «non poter comprare l'essenziale», ma del «non poter comprare per sentirsi parte della modernità». Secondo Bauman, autore di queste elaborazioni, il «povero», nella vita liquida, cerca di standardizzarsi agli schemi comuni, ma si sente frustrato se non riesce a sentirsi «come gli altri», cioè non sentirsi accettato nel ruolo di consumatore. Se si osservano da questa prospettiva varie tendenze dell’arte moderna, se ne rileva la condizione di precarietà e di breve durata nel tempo.
Fonte