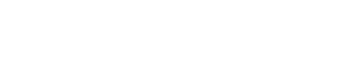Quando l’Italia era...
Quando l’Italia era…
Gli anni del Boom Economico
Totale assenza di inflazione, riconoscimento della lira come moneta più stabile del mondo, fervida attività industriale, livelli di consumo pari agli altri paesi Europei. Sogno o son desto? Ebbene sì, siamo nell’Italia degli anni Cinquanta, gli anni della ricostruzione e precisamente nel 1958, considerato l’anno chiave del cosiddetto miracolo economico italiano.
La rapida crescita economica è caratterizzata da una radicale trasformazione sociale: il crollo della realtà agricola e lo sviluppo del modello industriale urbano. La città, quindi, diventa il nuovo centro del progresso, della modernità, del consumo.
Nel 1959 la famiglia media era composta da quattro persone, si parla di quelle famiglie nate alla fine degli anni quaranta e che alla fine del decennio successivo diventano protagonisti del boom, ossia quelli che guadagnavano circa trecento mila lire al mese e che avevano usato il nuovo rivoluzionario strumento della rinascita economica: il pagamento a rate.
Sono le famiglie che, a differenza di quelle piccolo borghesi dell’anteguerra, superano la repulsione nei confronti di qualsiasi debito e comprano, lusingati dai consigli e dalle raccomandazioni provenienti dalle persuasive campagne pubblicitarie. Gli italiani comprano le case, avvalendosi dei mutui, acquistano grandi e piccoli elettrodomestici che hanno una durata sempre più breve e che quindi vengono sostituiti con estrema rapidità. Assieme alle dimore si modificano anche i mobili, le abitudini insomma lo stile di vita. Questa società diventa più colta, nelle case entrano più giornali, anche se, sarà la televisione la base dell’informazione comune.
Ma questa fotografia ci rivela un’Italia divisa in due. Intatti, al sud della nostra penisola la rinascita stenta ad arrivare e il tenore di vita rimane ancora basso.
Da un’inchiesta del settimanale l’"Espresso" emerge un’Italia meridionale molto povera, dove i pasti sono ancora frugali, dove la gente vive ammucchiata in pagliai assieme agli animali, dove in nessuna abitazione esistono i servizi igienici, dove il 70% della popolazione adulta è formata da piccoli pastori con armenti di 80-100 pecore, dove i paesi sono privi di strade, di acquedotti, di scuole e che la neve dell’inverno isola per settimane dal mondo civile; questa è la fotografia dell’Italia contadina nel 1958.
I protagonisti attivi di questo miracolo sono i giovani, essi, a differenza dei loro genitori, che hanno ancora vivo il ricordo della guerra e di tutte le sofferenze passate, i disagi e gli stenti, vivono con naturalezza le opportunità che si presentano loro quali la musica, il cinema, la Vespa.
Questa sarà una generazione che creerà e consumerà una propria musica, un proprio cinema, un proprio abbigliamento e che avrà contatti con altre culture. Essi si riveleranno molto sensibili all’acquisto di tutti i prodotti conosciuti attraverso la pubblicità. Diamo un’occhiata ai mezzi di comunicazione utilizzati dai pubblicitari.
Negli anni Cinquanta i quotidiani continuano ad essere il principale strumento finalizzato alla comunicazione, essi ormai contano più di cento testate e una tiratura di circa cinque milioni e mezzo di copie. Si modificano grazie anche alle nuove idee e le tecnologie importate dall’America, quali per esempio l’impaginazione o la veste grafica. L’introduzione delle pagine di carta patinata, che negli anni precedenti era stata una tecnica inaccessibile a causa dell’elevato costo di realizzazione, insieme alle prime applicazioni del colore generano un nuovo mezzo di comunicazione: il rotocalco. Tra i più famosi ricordiamo La Domenica del Corriere, la Tribuna illustrata e il Radiocorriere. Accade così che in quel decennio i tradizionali canali di comunicazione, ossia i quotidiani, dovranno confrontarsi con la concorrenza di due nuovi mezzi di notevole portata: i rotocalchi e la televisione. Quest’ultima ha iniziato le sue trasmissioni nel 1954 dando un notevole impulso alla trasformazione della pubblicità. Tuttavia, la televisione, pur generando tutta una serie di cambiamenti nella costruzione del messaggio pubblicitario, non si sostituirà mai alla pubblicità stampata, anzi favorirà l’incremento globale degli investimenti. In questo periodo anche il cinema avrà uno sviluppo repentino e quindi si aggiungerà agli altri mezzi di divulgazione pubblicitaria.
La pubblicità cinematografica è strettamente collegata alle sale di proiezione e alla fortuna dei film proposti. All’inizio, durante le prime cinematografiche gli annunci commerciali risentivano ancora molto della tipologia del manifesto; infatti, veri e propri manifesti venivano dipinti sul sipario dei teatrini adibiti a sala cinematografica oppure riprodotti, in modo artigianale, sulla lanterna magica che entrava in funzione durante gli intervalli. Al crescere dell’interesse della buona borghesia nei confronti del cinema, all’aumentare del livello sociale ed economico degli spettatori, di conseguenza, si modifica anche la qualità della clientela della pubblicità.
Tra i primi produttori di pubblicità cinematografica ricordiamo Vitrotti, Omegna e Comerio. Fu proprio Comerio a girare il film pubblicitario La Grande Italia, che aveva lo scopo di promuovere il prestito Nazionale per la ricostruzione; si trattava di un ardito montaggio di scene di sereno lavoro ed immagini di guerra, dove i fucili si trasformavano in falci, i mortai in aratri e i soldati, pronti all’attacco, in operosi contadini intenti a mietere.
Nel 1951 l’interesse nei confronti di questo tipo di pubblicità aumenta al punto tale che viene istituita, nell’ambito della fiera di Milano, la Rassegna Internazionale della Cinematografia al Servizio della Pubblicità, dell’Industria e della Tecnica, essa durerà otto anni. Nel 1954, in occasione della Mostra del Cinema a Venezia, comincia il primo Festival Internazionale del Film Pubblicitario, l’anno successivo la manifestazione si trasferirà a Montecarlo, e poi a Cannes; negli anni successivi, Cannes si alternerà con Venezia. Dal 1959, il Festival si dividerà in due sezioni: cinema e televisione. Mentre nell’ambito della pubblicità cinematografica, l’Italia, grazie soprattutto alle produzioni di animazione dei fratelli Pagot, si aggiudica parecchi premi, per quanto riguarda invece la sezione televisione sono gli americani a farla da padroni.
Questa manifestazione, in trent’anni di attività, determina la produzione di oltre duemila film ed è teatro di uno scontro tra cinema e televisione, dove rivaleggiano anche registi italiani di grosso calibro quali Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Sergio Leone e Gillo Pontecorvo. La pubblicità cinematografica dal 1981 non sarà più un settore a sé. Dal 1982 la pubblicità cinematografica perderà la sua autonomia.
In tutto questo contesto così effervescente e ricco di evoluzioni non si può trascurare la presenza di un altro mezzo di comunicazione consolidato da oltre vent’anni: la radio. In questi anni, la radio risente molto della nascita e della repentina affermazione della televisione, tuttavia, essa continuerà a svolgere la sua funzione, mantenendo viva l’attenzione del pubblico; la radio riuscirà a specializzarsi e, contrariamente alle attese di molti, non verrà mai soppiantata dal nuovo mezzo. Ma cosa avviene, in quegli anni, nel campo della pubblicità radiofonica? Bisogna sottolineare, prima di tutto, l’introduzione di alcune novità tecnologiche quali la maggiore mobilità degli apparecchi, l’applicazione dei transistor e la diffusione delle radio a modulazione di frequenza. L’introduzione della modulazione di frequenza (FM) determina da subito una moltiplicazione dei canali. I programmi di tali canali, guidati dai disc jockey, saranno rivolti al pubblico giovane che per i pubblicitari rappresenterà un target strategico.
La progressiva specializzazione, attraverso la creazione di programmi a tema, è il più significativo cambiamento in seno alla radio. Questi fenomeni, tutti insieme, hanno fatto della radio un mezzo di comunicazione dalla presenza stabile nelle case degli italiani e relativamente poco invadente.
Ma veniamo ora al rapporto radio-pubblicità. Nel corso della sua storia si sono definiti alcuni stili e strumenti propri della pubblicità sonora, che in parte sono rimasti propri di questo mezzo e in parte sono stati trasmessi ad altri mezzi, ne elenchiamo qualcuno: l’imbonimento, alle origini la pubblicità radiofonica era diretta e rasentava la brutalità, il nome del prodotto e l’intonazione erano gli unici elementi importanti, d’altronde un mezzo sonoro porta con sé la tentazione di affidarsi alla pura forza persuasiva della parola; il jingle è un modo di agevolare la memorizzazione del prodotto servendosi della musica o delle frasi ripetute che diventano motivetti orecchiabili (non dimentichiamo che, soprattutto ai giorni nostri, il jingle si fa immagine legando la pubblicità radiofonica a quella televisiva e diventa sempre più sofisticato in virtù delle sue citazioni da brani alti di musica classica e jazz). Come si diceva prima, la radio, dopo essere stata a lungo mezzo di comunicazione di massa e terreno di sperimentazione, oggi appare come "canale audio", vale a dire un semplice canale aggiuntivo a basso costo, troppo frammentato per essere un vero ed autonomo mass medium.
Tuttavia è opportuno ricordare che, anche ai giorni nostri, nelle campagne pubblicitarie di ampio respiro, il canale radio fa sempre in sinergia con gli altri mezzi pubblicitari e il messaggio radiofonico, sovente, viene utilizzato per rafforzare l’efficacia della promozione video e stampa del prodotto.
Tirando un po’ le fila di questa breve passeggiata storica possiamo concludere affermando che: negli anni Cinquanta inizia in Italia un cambiamento del concetto di pubblicità, progressivamente muta il concetto di réclame e si trasformano i vecchi modi di affrontare i problemi del mercato, questo perché a fronte di un cambiamento del mercato stesso, che, da qui in avanti, sarà basato sulla libera concorrenza; in questo nuovo contesto la pubblicità non sarà più solo l’anima del commercio, ma anche l’anima del sistema produttivo; essa farà conoscere le imprese e i prodotti, stimolerà le vendite, sosterrà ed incrementerà la produzione, insomma contribuirà fattivamente allo sviluppo economico del nostro paese. Spesso ci siamo chiesti quando sia iniziata la pubblicità moderna, ma non è possibile dare una risposta univoca, in quanto a seconda dei punti di vista si potrebbe individuare una data diversa. A mio avviso, il primo congresso nazionale sulla pubblicità, del 23 settembre 1950, potrebbe essere un punto di riferimento ufficiale; questo perché proprio in quella circostanza, il dottor Mario Bellavista, fondatore di una delle più prestigiose Agenzie di pubblicità italiane: lo Studio Sigla, presentò una relazione assolutamente innovativa sull’investimento pubblicitario delle aziende industriali. Egli, infatti, definisce la pubblicità come uno dei mezzi più efficaci per aumentare il reddito, precisando che in pubblicità non ci sono miracoli, ma solo dei rapporti precisi tra lo stanziamento e il suo rendimento, ossia qualità e quantità. Inoltre, durante questo congresso, si afferma la logica della legge del marketing, che matura in seguito alla consapevolezza di una radicale trasformazione del mercato. Infatti, se fin qui sono stati gli industriali a guidare il mercato attraverso i loro prodotti, da qui in avanti sarà il mercato a determinare la produzione.
…continua…