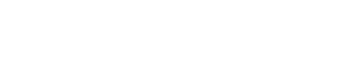Si superino le pigrizie
«Sicurezza: dovere assoluto. Diritto intoccabile» è uno dei messaggi della campagna sociale annuale messa a punto dalla Fondazione Pubblicità Progresso, che per il 2008 si è ispirata proprio ai continui richiami del Presidente Napolitano sul tema delle morti bianche. L’intento è quello di stimolare le coscienze attraverso un’azione di comunicazione coordinata ed efficace, affinché «si usi la testa per evitare la croce». Semplici e chiari slogan, le cui basi comunicative vogliono creare maggior consapevolezza ed abbattere storiche barriere culturali: fatalismo ed inerzia.
Una corretta visione della prevenzione può e deve indurre tutti gli attori verso quella organizzazione di apprendimento che salvaguardi il mantenimento della propria continuità riflettendo assiduamente sul e nel proprio contesto, in modo da poter fare affiorare una continua ridefinizione ed interpretazione dei significati delle proprie attività in relazione a tutti i livelli: ambientale di cui sono parte, dei sistemi in cui si organizzano e quello in cui l’essere umano come singolo, insieme ad altri singoli, partecipa con le proprie azioni, cognitive e comportamentali.
A seguire due curiosità, attinenti l’argomento, una delle quali risalente al 22 novembre 643. La prima associazione volontaria tra imprenditori avente scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro nacque nel 1867 a Mulhouse, in Alsazia, e tal esempio fu poi seguito in altri paesi europei da molti industriali persuasi che l'imprenditore non fosse debitore verso i propri operai soltanto del salario, ma fosse responsabile anche della loro salute. In particolare in Italia la prevenzione, collegata ai rischi presenti nell'industria, si è sviluppata parallelamente allo sviluppo industriale italiano che è iniziato prevalentemente a Milano ed in Lombardia tra il 1890 ed il 1915. Essa vide come attori principali gli "industriali benpensanti" dell'epoca inseriti "nell'Associazione degli Industriali per Prevenire gli Infortuni sul Lavoro", fondata nel 1894 da Ernesto De Angeli, con lo scopo di assistere i singoli industriali nella prevenzione degli infortuni.
Il Muratori trovò dunque negli archivi, dove giaceva sepolto e dimenticato, l'Editto di re Rotari, del 22 novembre 643 («decimo Kalendas Decembres DCXLIII»), composto di 388 articoli e redatto in latino. Re Rotari, primo legislatore dei longobardi (che regnarono in Italia per più di duecento anni, dal 568 al 774) pubblicò l'Editto dopo aver consultato i nobili in un'assemblea di guerrieri che si tenne a Pavia, il 22 novembre 643. Leggiamo nella Storia dei Longobardi di Paolo Diacono (IV, 42), da cui attingeremo ancora in seguito: «Rotari fece raccogliere per iscritto le leggi dei longobardi, affidate soltanto alla tradizione e alla consuetudine, la raccolta fu chiamata “Editto”. Correvano allora settantasette anni dalla calata dei Longobardi in Italia, come Rotari stesso afferma nel prologo dell’Editto». L’Editto tratta dei crimini contro il re, lo Stato e le persone, del diritto di successione e di famiglia, della successione. Gli articoli n. 144 e 145 che trattano dei Maestri Comacini e dei loro «colleganti» stabiliscono le norme da seguire in caso di infortunio sul lavoro.
Le immagini riprodotte provengono dal codice membranaceo (cm 25 x 18) Ms. CLXXXVII del secolo VIII, conservato nell' Archivio e Biblioteca Capitolare di Vercelli. Si tratta di un codice molto importante per la sua datazione, anche se gravemente mutilo. Nella traduzione del Merzario, che ripropongo inalterata per quel linguaggio antico che ben si adatta alla vetustà del documento, l'articolo 144 dice: «Se il Maestro Comacino co' suoi colliganti avrà assunto di restaurare o fabbricare la casa di chicchessia, fissato il patto della mercede, e accadrà che qualcuno muoia per la caduta della stessa casa, o del materiale o di una pietra: non si ricerchi del padrone cui appartiene quella casa, se il Maestro Comacino co' suoi consorti non comporrà lo stesso omicidio o il danno; imperocché avendo per suo lucro assunto nella fabbrica la ferma della mercede, non immeritatamente sostenga il danno».
C'è poi una specie di appendice o supplemento all'Editto, del 28 febbraio 713 («Pridie kalendas Martias, anno DCCXIII») di re Liutprando, con il titolo Mémoratorio de Mercedes Comacinorum. Dieci articoli riguardano i Maestri Comacini: una serie di norme per regolare i rapporti tra i committenti e i Maestri Comacini; un tariffario tecnico relativo alla costruzione dei muri, delle volte, degli archi, degli stucchi e ai lavori di carpenteria. Sebbene gli articoli suddetti accennino soltanto alla costruzione di palazzi e case e non ci aiutino nell'identificazione delle loro opere, resta il fatto che i Maestri Comacini erano tanto noti all'epoca del regno longobardo, che due re, a grande distanza di tempo l'uno dall'altro, ritennero di dover regolare le loro prestazioni nel corpo legislativo. E non è improbabile, come sostiene il Merzario, che fossero già attivi prima della venuta dei Longobardi in Italia, sotto i Goti e sotto i Bizantini, o che fossero addirittura la derivazione di un antico collegio di arti e mestieri romano.