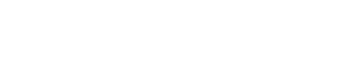Televisione cattiva maestra?
New York, sera del 24 aprile 2004, impegnato in una stanza d’albergo nello zapping tra una stazione televisiva e l’altra. Sulla UPM Nine, canale di tendenza, viene trasmesso Fear Factory, un reality show nel quale prima tre uomini si sfidano a chi riesce a mangiare un cervello crudo di animale e quindi tre donne vengono immerse fino al collo in un contenitore pieno d’acqua, che ricorda quello di Ciao Darwin (trasmissione trash del sabato sera andata in onda fino a quattro anni fa su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis, che del genere è forse uno dei migliori rappresentanti), nel quale sono quindi calati dei topi morti: la gara, ora, è tra chi riesce a prendere il maggior numero possibile di roditori con la bocca (quelli bianchi, che si contano sulle dita di una mano, valgono molto di più) e a depositarli sul bordo del recipiente. E fortuna che la Camera dei rappresentanti, appena due mesi prima, ha approvato a larga maggioranza (389 voti a favore contro soli 38 contrari) una legge contro la volgarità verbale televisiva che prevede multe salatissime (fino a mezzo milione di dollari) e finanche, nei casi più gravi, l’oscuramento dell’emittente colpevole.
Roma, pomeriggio dell’8 maggio 2005, ancora alle prese con lo zapping tra un canale e l’altro. Su Canale 5 va in onda Buona domenica, il carrozzone carnevalesco condotto da Maurizio Costanzo che indulge troppo alla soddisfazione degli appetiti più bassi (va un po’ meglio, ma solo un po’, per Domenica in, il contenitore domenicale di Rai Uno, condotto da Mara Venier, che ha avuto però quest’anno la peggio in termini di ascolti: 29 a 3 per Costanzo). Non siamo ancora ai livelli beceri della tv americana (raggiunti anche dalla televisione inglese) ma la strada intrapresa da certa recente tv italiana non lascia presagire nulla di buono. Gli esempi di pessimo gusto ormai non si contano. Dalla discussissima ospitata, all’ultimo Festival di Sanremo (presentato da Bonolis), di un Mike Tyson condannato per stupro all’assegnazione della palma di artista più puzzone, all’interno di una rosa di cinque nomi (Brad Pitt, l’insospettabile vincitore, Russell Crowe, Britney Spears, Mickey Rourke e infine il cane Rex, l’altrettanto insospettabile quinto arrivato), nella trasmissione di gossip Starflash, di vita fortunatamente breve, condotta su Rai Due da Jerry Calà e Elenoire Casalegno, agli scherzi da caserma a cui si assiste sempre più spesso nei tanti reality (come la pisciatina nella “cassetta del viaggiatore” di Marina Graziani, contenente i suoi effetti personali, nell’inguardabile Ritorno al presente, anch’esso per fortuna presto sospeso). Un pessimo gusto che fa il pari con le gratuite volgarità di cui si accenna nella doppia intervista a Morcellini e a Veneziani e alle quali se ne potrebbero aggiungere a decine.
Così per esempio, in diretta su Rai Uno, un improvvisato Totò (il solito Bonolis) alla fine del comizio di più di 40 muniti in onda nella puntata di Affari tuoi del 19 gennaio 2003, pochi giorni dopo la melodrammatica replica, sempre in diretta e questa volta dal salotto familiare di Domenica in, a uno spregiudicato Antonio Ricci (che per bocca dei conduttori di Striscia la notizia lo aveva accusato di speculare sul dolore):
Nella vita ci sono le cose reali e le cose supposte. Se da una parte mettiamo le cose reali, le supposte dove le mettiamo?
La televisione che per quindici lunghi anni accompagna le giornate del recluso incolpevole dell’ultimo, splendido film del coreano Park Chan-wook (Old boy), che ha avuto il “torto” di non avergli insegnato le parolacce (il protagonista se ne rende conto quando, una volta uscito dalla lunga prigionia, ha difficoltà a comprendere il frasario becero con cui lo apostrofano alcuni giovinastri) la vorremmo tanto anche da noi.
Ma non c’è solo volgarità in tv, c’è anche violenza[1]. A causa della televisione un quattordicenne adolescente americano, come ha messo in luce un’indagine compiuta alla fine degli anni Ottanta dalla newyorkese Columbia University, ha già potuto assistere mediamente a 8.000 omicidi e a 100.000 atti di violenza; e quando quell’adolescente ha raggiunto i 18 anni gli omicidi visti in tv sono diventati 40.000 e gli atti di violenza 200.000[2]. Troppa, pericolosa e per tutti i gusti, la violenza si configura ormai non soltanto come violenza mostrata in televisione ma anche come violenza inferta dalla televisione: una violenza, nella modellizzazione di Gili[3], spettacolarizzata, asettica, tiepida e del monopolio della parola. Sul banco degli accusati, ultimamente, si è seduto il wrestling, tipico esempio di violenza spettacolarizzata che ha suscitato le reazioni della Commissione bicamerale per l’infanzia: la sua Presidente, Maria Burani Procaccini, ha annunciato infatti nel maggio scorso una risoluzione che dovrebbe costringere la tv a far comparire il bollino rosso durante la messa in onda delle gare di questa lotta libera (targata USA, tanto per cambiare) e i canali a pagamento a trasmettere programmi che mettano in guardia giovani e giovanissimi dal tentativo di riprodurre le prese e le tecniche di combattimento degli energumeni che si combattono sul ring. E giovani e giovanissimi, intanto, emulano: non solo la violenza del wrestling[4] ma anche quella dei tanti film e telefilm trasmessi dal piccolo schermo. Mi viene in mente un esemplare episodio accaduto a Mario Pirani, che lo ha raccontato in un articolo apparso su «Repubblica» (14 maggio 2005), e incentrato sui numerosi fenomeni di bullismo giovanile[5] rimbalzati nelle cronache tra aprile e maggio di quest’anno. Vale la pena rinunciare a riassumerlo, anche se è un po’ lungo, e lasciare direttamente la parola a Pirani:
Ero andato a trovare una mia amica, madre di uno sveglio e intelligente ragazzino di 9 anni, di nome Albert, che, quando arrivo, stava protestando perché non gli era stato comprato un recente disco per la PlayStation, Grand Theft Auto San Andreas, collegabile alla TV, di cui «tutta la classe parla, anzi non parla d’altro». La mamma si rifiutava perché aveva subodorato il contenuto violento dell’agognato dischetto. Incuriosito chiesi se poteva farselo prestare per visionarlo. Nello spazio di 10 minuti, convocato d’imperio, arriva un bimbo, di nome Federico, all’apparenza più piccolo, ordinato e educatissimo[,] che si scusa gentilmente con me perché poteva rimanere solo mezz’ora. «Dopo debbo andare a catechismo» spiegò. Lì per lì restai deluso dall’informazione e pensai che lo spettacolo non poteva esser tale da terrorizzare spettatori tanto compiti. In effetti il solo terrorizzato dopo mezz’ora di visione sarò io.
Sullo schermo televisivo, con effetti tridimensionali e potenzialità interattive, i due ragazzi, al ritmo di una musica rap, si misero a guidare, con un apposito telecomando, personaggi realistici, anche se disegnati al computer, con ceffi e linguaggio da galera, che si muovevano rapidamente con potenti auto, moto ed altri mezzi di locomozione, ed anche a piedi. Lo scenario era quello di una città con vie, case, negozi, luoghi di svago di cui tre gang si contendevano il controllo. Nella «gara» il punteggio che ogni giocatore raggiunge è determinato dalle «missioni» che compie e viene valutato secondo parametri in cui primeggia il «rispetto» acquisito nell’uso delle armi, nella resistenza ai colpi, nei muscoli (che aumentano o diminuiscono secondo gli esercizi), nel sex appeal, ecc. Le armi variano dal mitragliatore a tre tipi di mitra e di mitraglietta, a due tipi di pistole, a fucili a pompa e a canne mozze, al bazooka, alla motosega, per scendere alla mazza, al coltello, al tirapugni e al manganello dei poliziotti. Le scene, animate dai piccoli giocatori premendo vari pulsanti del telecomando, sono semplicemente orripilanti.
Ecco qualche esempio: una prostituta viene afferrata, caricata sull’auto e sgozzata, il sangue rosso si sparge ovunque; un avversario è inseguito per strade e locali, tagliato in due con la motosega; ad un barista viene fatta saltare la testa con il fucile a pompa; un camion corazzato viene usato per una «missione» di scasso, i cadaveri dei guardiani trucidati finiscono schiacciati più volte sotto le ruote; un’auto parcheggiata appare scossa violentemente: effetto di uno stupro che si consuma al suo interno, previo rapimento della donna. Aggiungo a scopo di documentazione qualche frase del parlato: «Stendi quei coglioni, figli[o] di puttana! », «Fottilo! », «Vuoi spassartela, tesoro?, «Cosa cazzo hai in mente?».
Corresponsabile degli episodi di violenza fisica e verbale di cui, sempre più spesso, sono protagonisti proprio i giovani sarebbe, secondo Pirani, il nostro attuale sistema educativo, il cui permissivismo avrebbe ormai abbondantemente superato il livello di guardia. Il fallimento delle due recenti riforme in materia (quella “catto-comunista” voluta dall’ex-ministro Luigi Berlinguer e quella “aziendalista” promossa dall’attuale occupante il dicastero della Pubblica Istruzione, Letizia Moratti) passerebbe soprattutto per di qua, per le maglie sempre più lasche «di un sistema scolastico che ha praticamente abolito la durezza degli esami, i voti negativi, il rinvio a settembre (sostituiti da port-foli, crediti, debiti e 6 rossi), annullato la certezza e la generalità dei programmi (per una buona parte dell’orario lo studente “sceglie” corsi di personale propensione), le bocciature, le sospensioni (che possono in casi eccezionali venir comminate dopo contenziosi fra la parti e solo per decisione collegiale votata anche dai rappresentanti dei genitori e degli studenti, ecc.), ridotta a zero l’efficacia dissuasiva del voto di condotta» (ibid.). La soluzione proposta da Pirani? Un «ritorno all’ordine», conclude il giornalista (che mi trova pienamente concorde e che credo troverebbe concorde anche Luca Serianni, che tocca questo tema più avanti, nel suo intervento alla rubrica “Il punto”), «che aiuti i ragazzi di oggi e di domani ad affrontare con consapevolezza responsabile le difficoltà della vita adulta»; non uno «slogan reazionario», dunque, «ma un appello alla più elementare virtù civica. La libertà e la democrazia si affermano laddove sono chiari, condivisi, eticamente concepiti i limiti che ogni società e ogni individuo dev[ono] porsi e la cui trasgressione comporta una pena commisurata» (ibid.). Anche perché ormai comincia a patire gli stessi problemi della scuola primaria e secondaria anche l’università, che si vorrebbe trasformata, nelle intenzioni del legislatore, in una naturale, friendly, non traumatica prosecuzione degli studi superiori. In quel superliceo evocato sempre più spesso e a proposito del quale Pier Vincenzo Mengaldo, a proposito dell’attuale configurazione istituzionale delle Facoltà di Lettere, e delle Facoltà umanistiche in genere, ha speso parole giustissime, mettendo in guardia dai pericoli sottesi al semplicismo:
Si dice che il nuovo assetto della facoltà di Lettere, articolato al massimo ma per altro verso semplificato (c'è chi parla di superliceo), sia tale per venire finalmente incontro alla circostanza che non si ha più a che fare con un'università, una facoltà, d'élite, ma di massa. Punto di vista in apparenza ragionevole e fondato, quasi ovvio, ma che ai miei occhi appare invece non soltanto demagogico ma schiettamente antidemocratico (e del resto quale demagogia non lo è). È certo vero che nell'ultimo cinquantennio si è passati via via da una facoltà di Lettere, e università, d'élite a una di massa. Ma che si debba per questo abbassare il livello degli studi, è una conclusione non solo semplicistica ma errata, e offensiva per quelle masse. I nuovi soggetti e – attenzione – i nuovi ceti che si sono affacciati, come non succedeva un tempo, agli studi universitari, in questo caso umanistici, hanno invece assolutamente diritto a un insegnamento del più alto livello possibile, pari a quello dei tempi delle élite. Chi ragiona come sopra ragiona, penso senza rendersene conto, con una mentalità classista.
Nei nostri atenei forse un giorno la produttività dei singoli docenti, oggi misurata con i test anonimi di valutazione i quali, compilati dagli studenti, tornano nelle mani dei titolari delle varie discipline, potrebbe essere in futuro valutata dagli organi competenti sulla base del numero dei candidati “varati” agli esami: perché in un’ottica commerciale e aziendale, come ha osservato ancora Pirani nell’articolo menzionato poc’anzi, «il cliente ha sempre ragione».
La questione della qualità dell’italiano televisivo, di fronte alla volgarità e alla violenza dei modelli proposti ai vari livelli alle nuove generazioni e accarezzati o amplificati dal mezzo televisivo, sembrerebbe ben poca cosa. E invece si dovrebbe partire proprio da qui, dal settore (o dai settori) in cui ognuno di noi è chiamato, nel suo piccolo, a intervenire perché ne è parte, perché ne è chiamata a risponderne la sua stessa professionalità. Sarei tentato perciò di fare miei, magari rinnovandoli con l’apporto (che sarebbe davvero consistente) di nuovi materiali, i sacrosanti anatemi che Raffaele Simone, contro la dubbia qualità di certa lingua televisiva, ha lanciato per anni dalle pagine di «Italiano e Oltre». Già Grasso, nel suo sapido intervento, si è però espresso in proposito e tanto basta. Torno allora volentieri alla violenza della televisione e mi limito ad affidare alla riflessione dei lettori le parole di quasi commento con cui, nel tg serale del 3 dicembre 2004, un noto mezzobusto televisivo (cui non bastano evidentemente le pronunce sballate: Frejus, per esempio, è diventato per sua bocca /'frÁjus/) ha “condito” la notizia di un attentato dei separatisti baschi dell’ETA: «Non ci sono altro che quattro feriti». La violenza, ormai, ha creato in noi tanta assuefazione che non è mai troppa. Nient’altro che quattro feriti. È, questa volta, la violenza inconsciamente auspicata. Sarebbe stata sicuramente meglio l’ennesima strage. Solo per tenere alti gli ascolti, s’intende.
«[N]ella volgarità del mondo», ha detto Giorgio Bocca, «c’è qualcosa che non funziona. Non sai dire esattamente che cosa ma lo senti sulla tua pelle. Senti ridere e battere le mani quando a te viene voglia di sbadigliare o di piangere» («L’Espresso», 19 maggio 2005, p. 11). Chissà che non abbia allora ragione il personaggio del romanzo d’esordio dello scrittore catalano Carlos Ruiz Zafón, il barbone Fermín Romero de Torres, che nella Barcellona del 1954, parlando del nuovo messia, la neonata televisione, come dell’Anticristo, azzarda un pronostico sul futuro destino del mondo:
[i]l mondo non verrà distrutto da una bomba atomica, come dicono i giornali, ma da una risata, da un eccesso di banalità che trasformerà la realtà in una barzelletta di pessimo gusto[6].
A parte la facile ironia sui soliti pistolotti retrivi contro la modernità e le sue diavolerie, troppo spesso smentiti dall’andamento dai fatti (specialmente in materia di novità nel settore della comunicazione di massa[7]), sembra la storia recente della un tempo gloriosa Striscia la notizia, nella passata stagione costretta a inseguire il trash per tenere testa agli ascolti di Affari tuoi. E il giorno in cui si sono improvvisamente materializzate, tra i due perfidi conduttori che pure non aspettavano altro per farne carne da macello, prima Loredana Lecciso e poi, a distanza di tempo, Flavia Vento, lo sbadiglio e il pianto hanno lasciato il posto allo sconforto e alla disperazione dello sbalordito e alla fine rassegnato telespettatore. Perché, direbbe Umberto Eco, il testimone della cattiva televisione, per eccesso (la Lecciso) o per difetto (la Vento), è diventato in questo modo testimone di sé stesso[8]. E non è, caro Ricci, esattamente la stessa cosa.
[1] Cfr. Guido Gili, La violenza televisiva. Generi e modelli, in «Nuova civiltà delle macchine», 22/2 (2004), pp. 83-103.
[2] Cfr. Giancarlo Bosetti, Dal villaggio all’asilo d’infanzia (globale), in Karl Popper, Cattiva maestra televisione, a cura di Giancarlo Bosetti, Roma, Edizioni Reset, 20033 , pp. 7-67: 49 (prima ediz.: 1994).
[3] La violenza televisiva cit.
[4] Come nei vari episodi (accaduti a Verona, in Valsugana e ancora in alcune scuole perugine) che hanno spinto il Codacons e l’Osservatorio sui diritti dei minori a chiedere al prefetto di Roma, Achille Serra, di vietare ai minori di 14 anni l’ingresso alle esibizioni di questo “sport” svoltesi al Palalottomatica il 4 giugno scorso.
[5] A cui Elena Buccoliero e Marco Maggi hanno dedicato un recente e assai interessante volume: Bullismo, bullismi. Le prepotenze in adolescenza dall’analisi dei casi agli strumenti d’intervento, Milano, Franco Angeli, 2005.
[6] L’ombra del vento, Milano, Arnoldo Mondadori, 2004 [2001], p. 104.
[7] «La storia dei mezzi di comunicazione moderni è lastricata di equivoci e false profezie, di miopie e strabismi. “La televisione non conterà, nel corso della mia e della vostra vita, scriveva sicuro ai suoi lettori il cronista di The Listener, il giornale della radiofonia allora imperante, commentando le prime trasmissioni televisive ufficiali della britannica BBC nel novembre del 1936. E tre anni dopo, all’indomani dell’inaugurazione della Fiera Mondiale di New York, in cui la televisione era stata ufficialmente presentata negli Stati Uniti, lo scrupoloso reporter del New York Times annotava: “Il problema è, che con la televisione, la gente deve stare seduta, tenere i propri occhi fissi sullo schermo: la famiglia americana media non ha tempo per questo. Di conseguenza, i professionisti dello spettacolo sono convinti che la televisione non sarà mai una seria concorrente della radio”» (Carlo Sartori, Digitale terrestre: la televisione alla riscossa. Una rivoluzione che cambia (in meglio) gli operatori, i programmi, i sistemi televisivi, in «Nuova civiltà delle macchine», 22/2 (2004), pp. 11-19: 11).
[8] Cfr. Umberto Eco, Testimoniarsi addosso, in “L’Espresso”, 26 maggio 2005, p. 222.