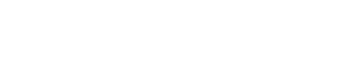Anche un esperimento non riuscito è una occasione per imparare.
Ricevuto l’invito, m’è parso evidente l’aspetto culturale volto a una riflessione in senso teologico, secondo i principi e i metodi della teologia e in senso stretto, con riferimento alla religione cattolica. Non ho titolo né competenza specifica inerente alla pittura d’immagine sacra, secondo la tradizione della Chiesa. Legittimo pertanto il mio disagio più che altro concettuale. Evidentemente non sono mai andato oltre alcune letture della liturgia per un riassetto interiore nei momenti che ritenevo sconvolgessero talune mie certezze. Buonsenso vuole che, anche in rispetto agli organizzatori, dessi segno di serietà. Ammessa senza alcuna remora la carente autorevolezza – ahi me –; in tutta coscienza non mi resta che significare il fatto implicito - tutto mio - con la massima discrezione. L’aver provato e non esserci riuscito non mi costerna più di tanto: fatta salva la sopportazione dell’uditorio annovero il tentativo come esercizio e mi appresto ad esplicitarlo nella sintesi possibile.
Iconografia, dall’enciclopedia Treccani: «disciplina relativa all’archeologia e alla storia dell’arte, che studia i temi figurativi (…), allo scopo di decifrarne i soggetti, e rintracciarne le derivazioni, le persistenze, le mutazioni. Essa contribuisce in tal modo a ricostruire i rapporti tra l’opera d’arte e il contesto storico culturale che l’ha prodotta, a riconoscere fattori che abbiano potuto incidere sui suoi aspetti stilistico-formali, a rilevarne analogie e legami con altre simili opere o altri ambiti di produzione». Identificando l’iconografia come disciplina che studia i temi figurativi, la preoccupazione e subito stata quella di discernere: «arte religiosa, arte sacra, arte liturgica» e inserirla in un contesto ben determinato per meglio definirne i significati. L’opportunità mi viene subito data dal resoconto del convegno, organizzato in collaborazione con l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Cei e dedicato a «Liturgia e arte, la sfida della contemporaneità». Riporto a seguire l’intervento di Albert Gerhards Università di Bonn. Il convegno ci ha mostrato che è necessario dare una definizione esatta dei concetti centrali: arte religiosa – arte sacra/cristiana – arte liturgica.
Arte religiosa – arte non religiosa. L‘opposto dell‘arte religiosa non è il profano, ma il secolare – la negazione di ogni trascendenza. Arte sacra – arte non sacra. L‘arte sacra tradizionale è andata in crisi. Perciò è nato l‘iconoclasmo nelle chiese moderne. La questione, se si possa continuare con l‘iconografia tradizionale, è aperta. Herbert Falken, pittore e teologo tedesco, scrisse come il suo undicesimo comandamento: «Tu non devi fare arte cristiana». Arte liturgica – arte non liturgica. Sono delle esigenze pratiche da parte della liturgia: il criterio di funzionalità. Un altro criterio è quello del luogo dell‘opera d‘arte nello spazio liturgico. Si deve distinguere fra opere d‘arte fisse e temporanee nelle chiese. Si è coscienti che c‘è un‘analogia fra liturgia e arte a causa delle sue strutture simboliche-sacramentali. L‘arte può essere un interrogativo a una liturgia non davvero celebrata. Da qui si pone la questione della bellezza, di cui parlano i documenti ecclesiastici. Di che qualità è una bellezza che include la gloria di Dio e la teologia della croce (H.U. von Balthasar)?
Alcuni esempi presentati dimostrano che il dialogo con grandi artisti del nostro tempo aiuta molto a trovare soluzioni convincenti e di prospettive per il futuro. Il presupposto per un dialogo fruttuoso da parte della Chiesa sono una teologia e una spiritualità autentica e una vera ars liturgica come arte primaria. L‘arte contemporanea – permanente o temporanea – può aiutare per una comprensione migliore dell‘arte tradizionale nella chiesa e per una performance migliore della liturgia stessa. Per superare lo iato fra il concetto tradizionale dell‘arte sacra e il concetto del dialogo con l‘arte contemporanea sotto l‘aspetto del religioso bisogna studiare le esperienze di incontri fra chiesa e arte che sono riuscite. Si dovrebbero scambiare le esperienze nelle commissioni diocesane e nazionali per l‘arte sacra e in altre istanze (p.e. i centri del incontro, le facoltà teologiche) per accrescere la sensibilità per la dimensione artistica. Anche un esperimento non riuscito è una occasione per imparare.