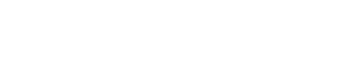La Spigolatrice di Sapri
Fin da giovinetto, appresa questa poesia, ne fui sedotto sia dalla metafora sia dal componimento lirico: dell’una affascinato e coinvolto, dell’altro estasiato e toccato. Un’impresa patriottica già tragicamente fallita, dai cui versi traspare la speranza di un felice esito della spedizione e, al tempo stesso, nelle strofe finali, il drammatico epilogo dell’avventura. Spesso col passar degli anni si son succeduti confronti e affinità nel quieto vivere; sempre ne è conseguita un’ovvia deduzione: mai questione di generi bensì di opportunità. E lo spigolare mi fu sempre caro.
A ragion veduta ne feci anche oggetto su La mia pagina Web, forse ostentandone l’uso di un modo di agire piuttosto personale e avanti con i tempi; che non voleva assolutamente essere una vanteria, bensì, nel continuo “spigolare” perseguire l’opportunità. «L'imprenditore deve riscoprire lo "spirito d'impresa" attraverso forme di forte motivazione in grado di essere trasferita su tutti quelli che partecipano agli eventi imprenditoriali», scrive Gianfranco Dioguardi. Si appalesavano segni premonitori: nella crisi cultura dal maggio 68, con la crisi ecologica dal 1972 e la crisi sociale dal 1986; mentre a me capitava l’occasione nello svolgimento di gestione di cantieri prevalentemente con una tra le più importanti Compagnie Italiane di Montaggi Industriali.
Scommettendo sull’opportunità di poter valutare accuratamente l’importanza di valorizzare e organizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze, cioè il valore del capitale intellettuale dell’azienda, mi è stato consentito l’uso di strumenti di programmazione reticolare: il (Project Evaluation and Review Technique) e il (Critical Path Method); due strumenti di Project Management volti alla schedulazione delle attività che compongono il progetto e, più in generale, alla gestione degli aspetti temporali di quest’ultimo. «Molto spesso questi due strumenti, che da un punto di vista accademico rimangono pur sempre distinti, sono considerati insieme, perché la sola differenza tra i due è la tipologia di durate delle attività considerate: stocastica nel primo caso, deterministica nel secondo». [1]
E lo spigolare mi fu sempre caro.
Derivato dal francese antico e privo di un sostantivo corrispondente nella lingua italiana, il termine anglosassone “governance” negli ultimi venti anni è diventato popolare nel dibattito politico e accademico. La stessa definizione del concetto ha subito cambiamenti e integrazioni, seppure in generale si possa sostenere che economisti, politologi ed esperti di relazioni internazionali, l’hanno usato, innanzitutto, per marcare una distinzione, e una contrapposizione con il “government” inteso quale istituzione, apparato e organizzazione.
Nell’accezione di ‘insieme dei principi, dei modi, delle procedure per la gestione e il governo di società, enti, istituzioni, o fenomeni complessi, dalle rilevanti ricadute sociali’, il sostantivo aziendalistico-imprenditoriale governance, dritto dritto nell’italiano e nelle altre lingue europee del cosiddetto mondo economicamente più sviluppato, si impone, trasvolando l’oceano Atlantico, dagli inizi degli anni Novanta del Novecento (il GDU, diretto da Tullio De Mauro, certifica il 1988 come data della prima attestazione nell’italiano scritto).
L’anglicismo, che propriamente vuol dire ‘modo di dirigere, conduzione’, inizialmente ha battuto e ribattuto sulle pagine della stampa italiana le piste del mondo dell’impresa, soprattutto perché abbinato all’aggettivo (anglosassone pure lui) corporate’aziendali’, nella locuzione corporate governance (in italiano dal 1994), che vale, «nel linguaggio aziendale, il metodo e la struttura organizzativa con la quale si distribuisce il comando tra i dirigenti di un’impresa» (Treccani.it).
Immagine: scuoleveronasantalucia