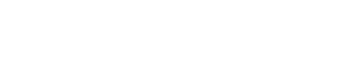Individuare obiettivi e traguardi specifici.
Il sapere di «milioni di intelligenze umane» è sempre al lavoro, si smaterializza passando dal testo stampato alla rete, si amplifica per la sua caratteristica di modificabilità, si distribuisce di computer in computer attraverso la rete stessa. Trovo tutto sommato interessante ed in un certo qual modo distensivo adoprarmi e, per quanto possibile, essere tra coloro i quali mostrano ottimismo nel sostenere che impareremo a costruire una conoscenza nuova, non totalitaria, dove la libertà di navigazione, di scrittura, di lettura e di selezione dell’individuo o del piccolo gruppo sarà fondamenta della conoscenza, dove per creare un nostro punto di vista, un nostro sapere, avremo bisogno inevitabilmente della conoscenza dell’altro, dove il singolo sarà liberamente e consapevolmente parte di un tutto. L’utilizzo dei materiali disponibili è visto come la naturale valorizzazione di una conoscenza liberamente e immediatamente disponibile. Da questo punto di vista, il criterio secondo il quale «conta solo ciò che è farina del proprio sacco» suona obsoleto. In conformità a questa considerazione, lo sfruttamento sistematico d’internet permette a molti di comporre in poco tempo brevi dissertazioni interessanti, salvo il fatto che sono quasi per intero mere riproduzioni.
L’aumento della connettività ci sta rendendo sempre più consapevoli di tutti i rapporti che compongono un mondo così complesso e vario. «Una nuova generazione sta cominciando a vedere il mondo sempre meno come un deposito di beni da espropriare e possedere, e sempre più come un labirinto di relazioni cui accedere. In che modo, dunque, sceglieremo di usare la nostra coscienza relazionale appena acquisita? È interessante notare come, proprio mentre cominciamo a sviluppare una consapevolezza relazionale della coscienza, cominciamo anche a capire la natura relazionale delle forze che governano il pianeta»[1]. La politica come professione è il titolo di una conferenza tenuta dal sociologo tedesco Max Weber. La politica è non solo una professione, ma, nello specifico, una vocazione. Così come esplicitato nel titolo originale del suo intervento “La politica come vocazione” Politik als Beruf, dove il tedesco Beruf è espressione di un’ambivalenza lessicale oscillante tra «mestiere» e «chiamata». Il sociologo definisce la politica come un’«attività autonomamente direttiva»[2], volta a dirigere e a influire sulla direzione dello Stato, che è dunque il locus specifico d’azione della politica.
Fare della politica la propria professione, il proprio ethos o il proprio daimon, può avvenire secondo due modalità: «O si vive “per” la politica, o si vive “della” politica. Ma un modo non esclude l’altro. Chi vive “per” la politica, ne fa in un senso intimo la propria vita […]. “Della” politica come professione vive chi cerca di farne una fonte duratura di reddito; “per” la politica, invece, vive colui per il quale ciò non accade». Quale dei due modi di vivere sia più condivisibile o incontri e assorba l’una nell’altra non dovrebbe essere in questione, benché secoli prima di Weber un suo illustre predecessore, Aristotele, avesse avuto pazienza di riflettere su qualcosa di simile, allorché, tuonando contro i “falsi politici”, scrisse: «la maggioranza di coloro che si dedicano alla politica ricevono questa denominazione non correttamente. Infatti, essi non sono politici secondo verità, perché l’uomo politico è colui che sceglie le azioni belle per se stesse, mentre la maggior parte sceglie questo genere di vita in vista delle ricchezze e del desiderio di potere».[3]
È sorprendente l’attualità del pensiero aristotelico? Piuttosto direi che attualizza, effettualizza dall’antichità una impasse che, nel corso dei secoli, non ha mai trovato, o forse neanche cercato, soluzione: perché si fa politica e sulla base di quale idea o formazione? Al fine di non scadere nel dilettantismo o nella «politica d’occasione», avrebbe detto Weber, subitaneo si richiede un approfondimento di quanto problematizzato, cioè etimologicamente, “gettato davanti”.[4]
Immagine: http://www.vemarsrl.eu/la-nostra-politica/
[1] (Jeremy Rifkin, La civiltà dell’empatia, p.550)
[2] I passi citati in questa sezione sono tratti dall’opera di M. Weber, La politica come professione, Mondadori, Milano 2009
[3] Aristotele, Etica Eudemia I 5, 1216a 23-28. Secondo il pensiero aristotelico la filosofia deve occuparsi della politica,in quanto essa è la ricerca del bene e del vivere bene - ciò che noi oggi definiamo “bene comune” - nella dimensione della città e dello Stato. Il vero politico compie per il bene comune kalài pràxeis, azioni belle non per sé, ma nell’interesse generale, a differenza del “falso politico” che agisce solo in vista del mero interesse personale.
[4] Il termine greco problema significa “ciò che è gettato davanti come ostacolo”.