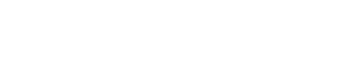Aspetti semiotici, sociologici e culturologici della pubblicità
2.3 Hebdige: cose e consumi
Nell’opera di Dick Hebdige dal titolo in italiano “La lambretta e il videoclip”19 vengono esplorati l’invenzione ed il consumo di miti ed oggetti di moda dal secondo dopoguerra sino ad oggi.
Ritornano periodicamente in queste pagine alcuni problemi concernenti da un lato il rapporto fra consumo, cultura e design, fra Pop, cultura popolare e postmoderno, e dall’altro lato fra la crisi della critica radicale e i limiti della conoscenza generale.
E’ ricorrente in questo libro anche il riferimento alle sottoculture, agli oggetti della cultura popolare e alla moda e alla pubblicità. Hebdige ci mostra come da una parte ci sia la donna che è influenzata dalla pubblicità ad acquistare alcuni prodotti, mentre dall’altra parte la stessa pubblicità si riempie di oggetti “sessualizzati”, la cui natura è determinata dal tipo di pubblico al quale si rivolgono. Scrive l’autore:
“Lo sviluppo della moderna industria pubblicitaria è spesso associato all’accresciuto potere d’acquisto del consumatore femminile o al crescente influsso esercitato dalle donne sulla spesa del nucleo familiare”.(Hendige, 1991: p.91)
Da questa affermazione, come si accennava in precedenza, Hebdige continua col dire che la sessualizzazione dell’oggetto è il primo passo della sua discesa dal “paradiso di Metropolis” al posto “destinato” nell’ordine esistente (vale a dire caduco e imperfetto) delle cose. Nelle società industriali avanzate, la trasposizione delle caratteristiche di genere sessuale in oggetti inanimati è segnata in modo peculiare. Tipicamente le qualità e lo status attribuiti al genere sessuale dell’utente ideale vengono trasferiti all’oggetto stesso. Proprio per questo motivo di “riconoscibilità” ed “assegnazione” dell’oggetto ad un particolare e preciso tipo di utenti, la sessualizzazione del prodotto è divenuta una delle tecniche principali della pubblicità, come ci suggerisce Hebdige, infatti, gli annunci pubblicitari sono decisivi per la definizione delle differenze sessuali. Talvolta l’oggetto è scisso, duplicemente, nei due aspetti opposti, quelli maschili e quelli femminili. Maschili sono gli aspetti funzionali, rigorosi, utili; femminili sono gli aspetti decorativi, piacevoli, gratificanti. La distinzione corrisponde alla separazione di funzioni progettuali: maschile è la funzione ingegneristica, femminile quella di styling. I rapporti di dominio e subordinazione inscritti nella divisione sessuale del lavoro vengono trasposti in modo tale che la funzione ingegneristica sia percepita come superiore e necessaria (maschile/produttivo), la funzione di styling come subordinata e superflua (femminile/improduttivo). Dunque il consumismo ha prodotto nuove esigenze e nuove categorie, in effetti la diffusione del consumismo s’intende riferita alla sostanziale ingenuità e imprevidenza femminile.
L’indicazione della deferenza sessuale si muove lungo una catena che corre incessantemente: uomo/donna: lavoro/piacere: produzione/consumo: funzione/forma, ecc. La caratterizzazione e le priorità del “maschile” e del “femminile” sono state istituzionalizzate a livello pedagogico nella distinzione fra soggetti “morbidi” e “duri”: l’ingegneria è inserita nelle facoltà universitarie come disciplina scientifica, mentre la moda , e la storia della moda, doppiamente subordinata – è soltanto un’ “arte applicata” – ed è eminentemente superflua.
Un esempio della manipolazione pubblicitaria dell’immagine di un oggetto al fine di renderlo facilmente identificabile con una certa categoria di consumatori (ciò che Hebdige chiama “identità di prodotto”) è rappresentato dal caso dello scooter dal nome Lambretta della casa produttrice Innocenti. Quando l’Innocenti iniziò le esportazioni della Lambretta a New York nei primi anni Sessanta, gli scooter vennero messi in mostra (e talvolta venduti ) non in saloni per auto o motocicli, bensì in esclusivi negozi di moda femminili. Furono visti come un ottimo addobbo per le vetrine, e considerati, più come mezzo di trasporto, come lussuosi accessori di metallo, come gioielli su due ruote. Lo scooter è individuato (insieme a “concorsi di bellezza e film”) come catalizzatore nell’“emancipazione” della nuova donna italiana (“il motor scooter le ha dato nuovi orizzonti”). E’ considerato inoltre diretto responsabile dei cambiamenti successivi nella moda femminile italiana dalla guerra in poi. Un altro esempio di come un’immagine parla dell’oggetto che vuole descrivere è quello dell’automobile francese Citroёn DS 19 (abbreviazione di Diffusion Special) che, non a caso, nella lingua francese si pronuncia Déesse (divinità femminile, Dea).
Hebdige sostiene che, se fosse stato un ingegnere o un piazzista che agognasse il possesso di un’automobile in grado di impressionare i potenziali clienti, allora il problema sarebbe stato concepito diversamente e diversamente esposto. Se avesse condiviso l’interesse per la meccanica e per il progresso (meccanica come metafora del progresso) che senza dubbio nutriva l’ammirata reazione di molti dei supplici che sfilavano per lo stand Citroёn nel 1955 e desideravano, anch’essi, possedere la Dea, allora, certamente, noi pure saremmo stati di fronte ad un oggetto diverso, a una diversa alienazione. Perché, come scrive l’autore:
“…lungi dall’essere silenziose, il numero delle voci che parlano attraverso e in vece delle cose mute è sterminato. L’enigma dell’oggetto non è tanto nel suo silenzio, nella sua supposta esistenza, quanto piuttosto nel brusìo che cresce intorno ad esso”. (Idem: p.83)
Analizzando il ruolo delle donne all’interno della società, Hebdige traccia con fermezza un resoconto di ciò che erano prima degli anni Cinquanta e Sessanta e quello che le donne sarebbero diventate negli anni Settanta ed Ottanta, nel momento in cui le ragazze sono state fino a poco tempo fa relegate in posizione d’interesse secondario sia nei resoconti sociologici della sottocultura sia negli studi fotografici della gioventù urbana. Il pregiudizio maschilista è tuttora presente nelle sottoculture stesse. Soggette a più stretti controlli familiari dei ragazzi, immobilizzate fra le doppie stimmate di essere considerate “frigide” o “scarti”, le ragazze nelle sottoculture, in specie nella sottocultura operaia, sono state tradizionalmente ridotte al silenzio o ricostruite nell’immagine dei ragazzi come surrogati… Quella tradizione è stata infranta, o almeno riformata, dal punk e dal postpunk, in cui le ragazze hanno iniziato a divertirsi fra loro in pubblico: parodiando la convenzionale iconografia della perduta femminilità – la vamp, la sgualdrina, la derelitta, la maitresse sadica, la vittima incatenata. Quelle ragazze interrompono il flusso delle immagini. Rievocano immagini di donne come icone, donne come le Furie della mitologia classica. Rendono inconsueta la matrice sadomaso. Rasentano il tema voyeuristico, civettano con la curiosità maschile ma rifiutano la sottomissione agli sguardi autoritari. A conferma di questo cambiamento sociale presente anche nelle sottoculture, l’autore cita una famosa canzone del gruppo musicale Talking Heads dal titolo “Road to Nowhere” composta nel 1984 e accompagnata da un video musicale, concludendo che, alquanto distante dall’affermazione della gente comune, del riso rispetto alla paura, della specie rispetto all’esistenza individuale, della vita rispetto ad ogni genere di “corso fatale”, Road to Nowhere si presenta (fra l’altro) come allegoria affermativa della “perdita del dominio (maschilista)”. Ciò significa che la detronizzazione non può essere contrastata, o respinta, ma solo accettata e ben accolta. Anziché vedersi offrire la morte dei soggetti e degli autori, la fine del Grande Rifiuto, il declino del vecchio potere della critica penetrante e della totalizzazione, ci viene offerta invece la nascita di qualcosa di nuovo e migliore – almeno di qualcosa di più brillante e fresco di noi stessi. Ci viene offerto qualcosa di più lieve e vivibile: un mondo in cui crescere, da cui farsi educare, un mondo in cui e per cui gli uomini (ancora una volta il genere sessuale è marcato) possano almeno iniziare ad assumere responsabilità senza sentirsi responsabili per l’intero Ordine Simbolico. Il momento in cui la corona di cartone colpisce la testa dell’uomo e cade a terra è teso a provocare riso e non angoscia, sollievo e non disperazione. L’autore dice a proposito della visione delle ultime scene di questo videoclip: “Io ho riso comunque. Ho provato sollievo.”[Idem: p.256)
8 G. Dyer, Advertising as Communication, Routledge, London and New York, 1982.
9 Per una discussione più approfondita sulla sociosemiotica, sono interessanti il primo ed il secondo capitolo del testo: G. Marrone, Corpi sociali. Processi comunicativi e semiotica del testo, Einaudi, Torino, 2001.
10 Martineau è il padre fondatore degli studi sulla motivazione in pubblicità. Uno dei suoi testi più interessanti è: P.Martineau, Motivazioni e pubblicità, ETAS Kompass, 1964.
11 (Cfr. S. Traini,Corso di semiotica, dispense a.a.2000-2001,Università di Teramo,2001.)
12 A tal proposito si veda: F. Marciani e A. Zinna, Elementi di semiotica generativa, Esculapio, Bologna, 1991.
13 J. M. Floch, Semiotica, marketing e comunicazione. Dietro i segni le strategie, FrancoAngeli, Milano, 1992.
14 Sui prodotti come segno si può consultare: E.Dichter, Gli oggetti ci comprano, Ferro Edizioni, 1967.
15 R. Barthes, Mythologies, Éditions du Seuil, Paris, 1957(tra.it. Miti d’oggi, Torino, 1994).
16 D. Kellner, Media Culture, Routledge, New York, 1994.
17 Molte analisi sui testi di Barthes si possono trovare in: P.Fabbri e I. Pezzini( a c. di), Mitologie di Roland Barthes, Pratiche Editrice, Parma, 1986, che contiene inoltre un intervento interessante di Umberto Eco su Roland Barthes fatto al convegno di Reggio Emilia del 13-14 aprile 1984.
18 J. Baudrillard, Il sogno della merce, Lupetti & Co., Milano, 1987.
19 D. Hebdige, Hiding in the Light. On Images and Things, Commedia/Routledge, London, 1988 ( tra.it. La lambretta e il videoclip, E.D.T., Torino, 1991).